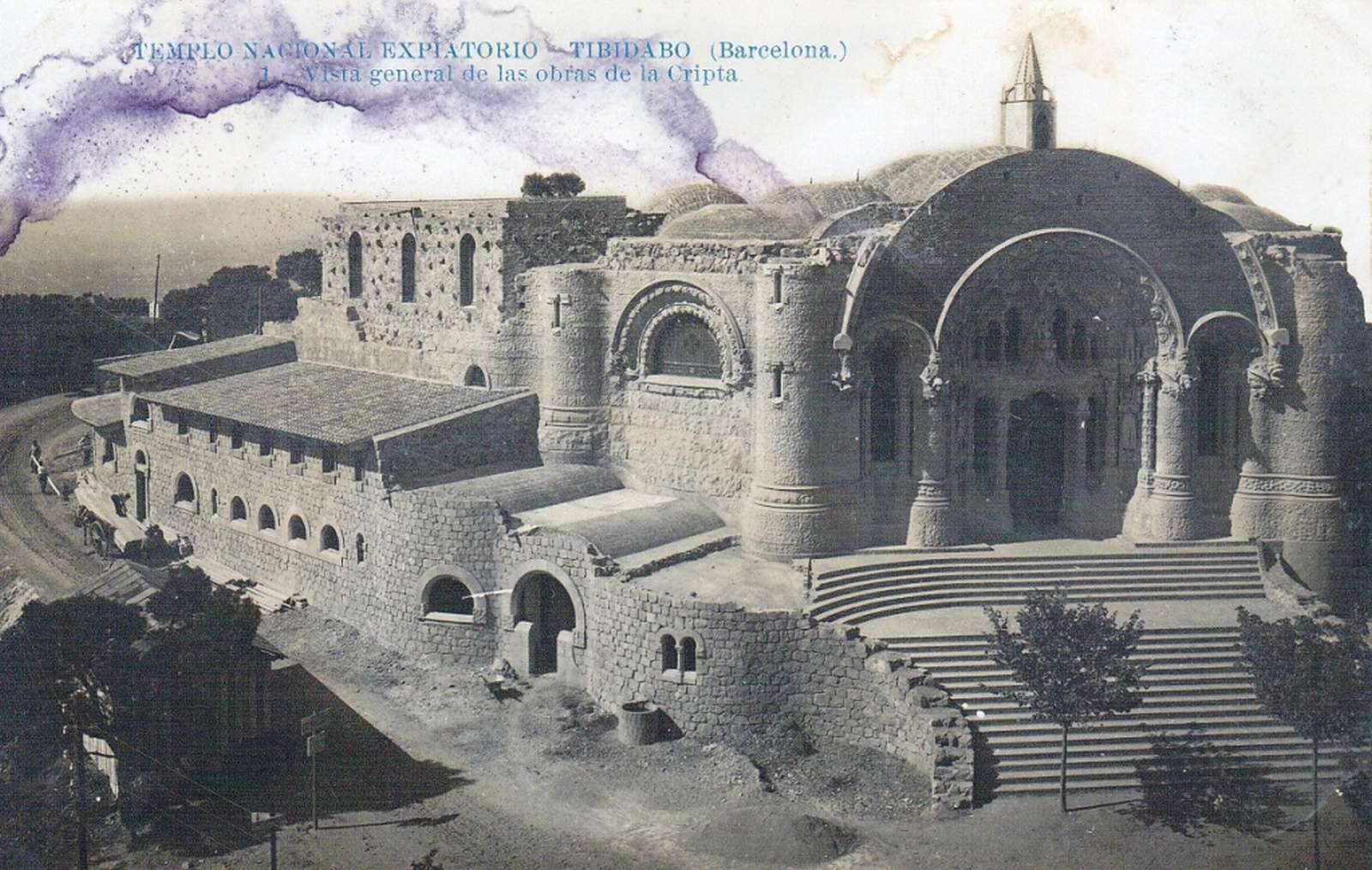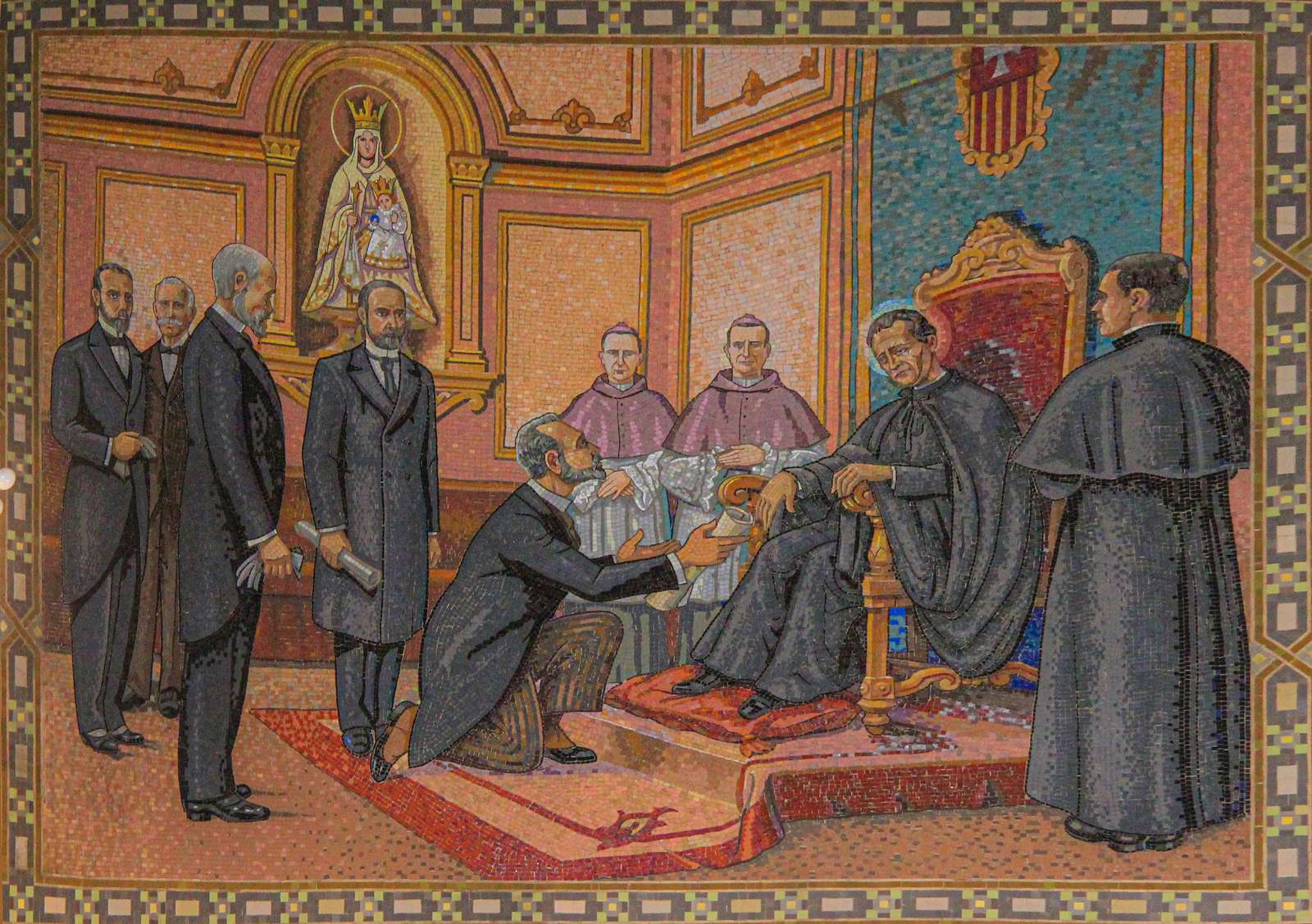Hai pensato alla tua vocazione? San Francesco di Sales potrebbe aiutarti (2/10)
(continuazione dall’articolo precedente)
2. Che fare domani
Cari giovani,
voi vi chiedete certamente: che cosa faremo più tardi, che cosa aspettarsi dalla vita? A che cosa siamo chiamati? Sono delle domande che ciascuno si fa, in modo cosciente o anche non cosciente. Forse conoscete la parola vocazione. Che strana parola: vocazione! Se preferite, possiamo parlare di felicità, di senso della vita, di voglia di vivere…
Vocazione vuol dire chiamata. Chi chiama? Questa è una bella domanda. Forse qualcuno che mi vuol bene. Ognuno di noi ha la sua vocazione. La mia è stata un po’ particolare. Nella mia Savoia, quand’ero piccolo, a undici anni, mi sentivo chiamato a darmi a Dio a servizio del suo popolo, ma i miei genitori, in particolare mio padre, avevano altri progetti per me, che ero il primogenito della famiglia. Col passare degli anni e durante gli studi che mio padre mi fece fare a Parigi, il mio desiderio è cresciuto sempre di più: grammatica, lettere, filosofia, ma anche equitazione, scherma, danza…
A 17 anni ho avuto una crisi. Riuscivo bene negli studi, ma il mio cuore non era soddisfatto. Cercavo qualcosa… Durante il carnevale a Parigi un mio compagno mi vide triste: “Che cosa non va, sei malato? Andiamo a vedere il carnevale”, “ma io non voglio vedere il carnevale”, gli risposi, “voglio vedere Dio!”. In quell’anno un famoso professore di Bibbia spiegava il Cantico dei Cantici. Andai a sentirlo. È stato per me come un colpo di fulmine. La Bibbia era una storia di amore. Avevo trovato Colui che cercavo! E con l’aiuto del mio accompagnatore spirituale, feci un piccolo regolamento per ricevere Gesù nell’Eucaristia il più spesso possibile.
A 20 anni mi colpì una nuova grave crisi. Mi ero convinto che sarei andato all’inferno, che sarei stato eternamente dannato. Ciò che mi addolorava di più, oltre a naturalmente la privazione della visione di Gesù, era di essere privato della visione di Maria. Questo pensiero mi torturava: quasi non mangiavo più, non dormivo più, ero diventato tutto giallo! La mia preghiera era questa: “Signore, io lo so, andrò all’inferno, ma fammi almeno questa grazia che quando sarò all’inferno, io possa continuare ad amarti!” Dopo sei settimane di angoscia mi recai in chiesa davanti all’altare della Madonna e la pregai con una preghiera che comincia così: “Ricordati, o vergine Maria, che non si è mai udito che alcuno, ricorrendo al tuo patrocinio, implorando il tuo aiuto e la tua protezione, sia stato da te abbandonato”. Dopodiché il mio male cadde a terra “come le scaglie della lebbra”. Ero guarito!
Dopo Parigi mio padre mi mandò a Padova per studiare diritto. Intanto continuai a soffrire del mio dilemma vocazionale: sentivo che la chiamata veniva da Dio, e allo stesso tempo dovevo obbedienza a mio padre, secondo le usanze molto sentite nel mio tempo. Ero perplesso. Ho cercato consiglio presso i miei accompagnatori, in particolare presso il Padre Antonio Possevino. Con il suo aiuto e il suo discernimento, scelsi alcune regole ed esercizi per la vita spirituale e anche per la vita in società con i compagni e ogni tipo di persone. Alla fine dei miei studi feci un pellegrinaggio a Loreto. Sono rimasto come in estasi – dicono i miei accompagnatori – per una mezz’ora nella Santa Casa di Maria di Nazaret. Ho affidato di nuovo la mia vocazione e il mio futuro alla Mamma di Gesù. Non mi sono mai pentito di essermi fidato totalmente di Lei.
Tornato in patria all’età di 24 anni, mi incontrai con una bella ragazza, chiamata Francesca. Ella mi piaceva, però mi piaceva di più il mio progetto di vita. Che fare? Non ti racconto qui tutti i dettagli della mia battaglia. Sappi soltanto che alla fine ho osato chiedere a mio padre che mi desse il permesso di seguire il mio sogno. Finalmente ha accettato la mia scelta, ma piangeva.
A partire da quel momento la mia vita cambiò completamente. Prima la famiglia e i miei compagni mi vedevano tutto concentrato su me stesso, preoccupato, un po’ chiuso. Allora da un momento all’altro, tutto si mise in moto. Ero diventato un altro uomo. Fui ordinato sacerdote a 26 anni e mi lanciai subito nella mia missione. Non avevo più dubbi: Dio mi voleva su questa strada. Ero felice.
La mia vocazione, penserete voi, era una vocazione speciale, anche se vi dico che sono stato fatto anche vescovo di Ginevra-Annecy a 35 anni. Nel mio ministero pastorale e di accompagnatore, mi sono sempre convinto e ho insegnato che ogni uomo ha vocazione. Anzi, non si dovrebbe dire: ognuno ha una vocazione, ma si dovrebbe dire: ognuno è una vocazione, cioè una persona che ha ricevuto un compito “provvidenziale” in questo mondo, nell’attesa del mondo futuro a noi promesso.
Ufficio Animazione Vocazionale