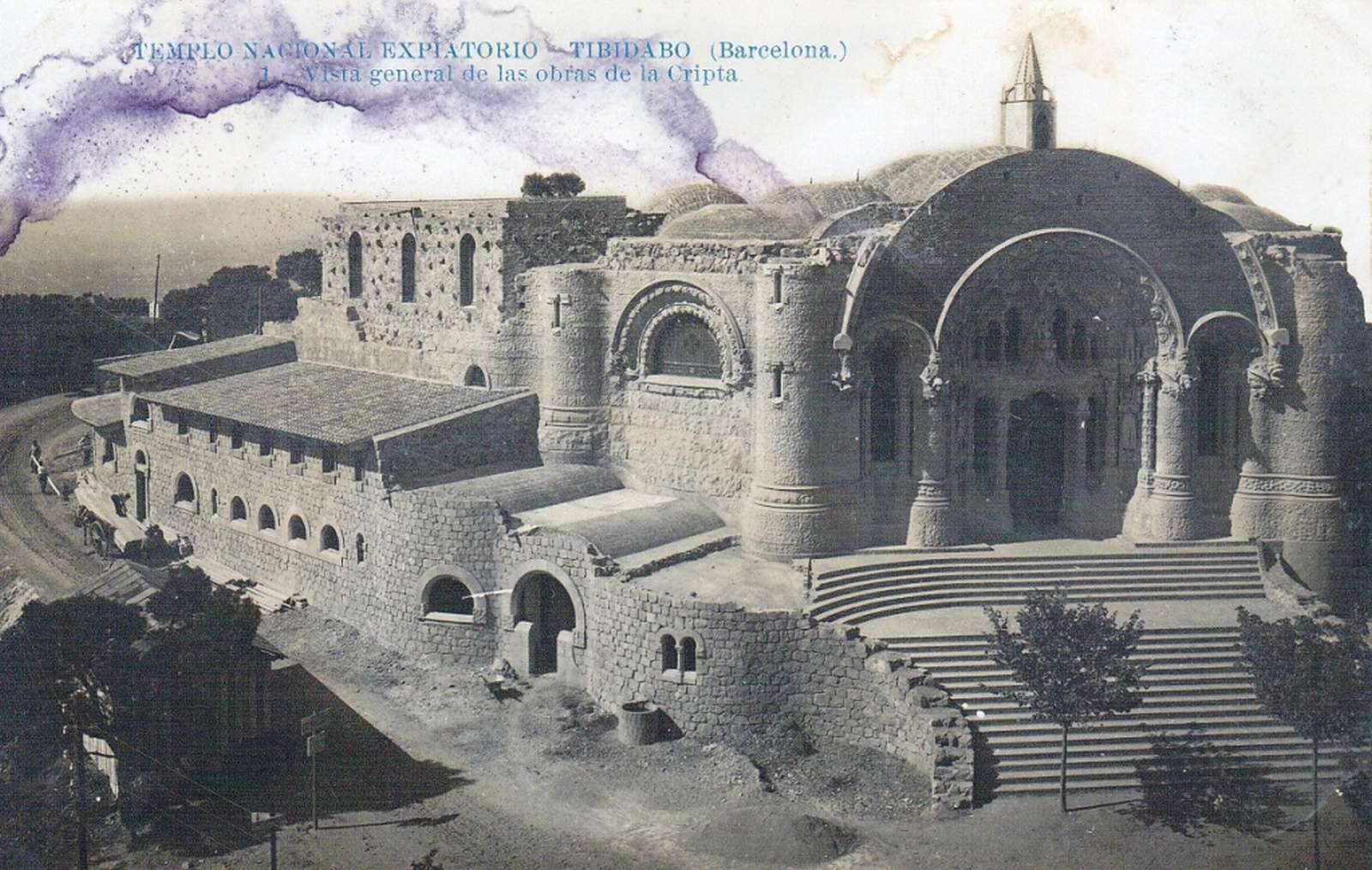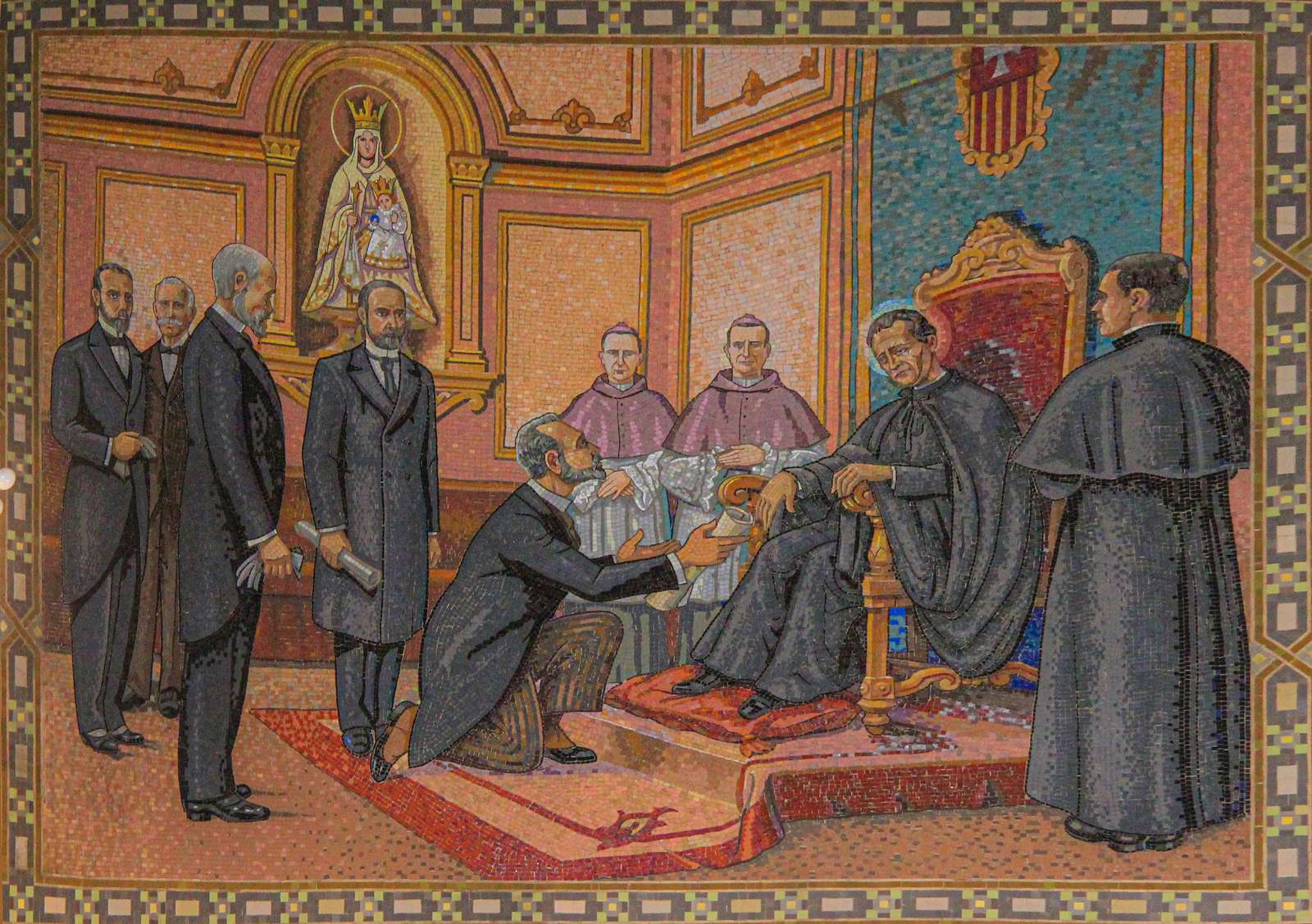Presentiamo la Stemma di Sua Eminenza Reverendissima, il signor cardinale Ángel FERNÁNDEZ ARTIME SdB, Rettor Maggiore della Pia Società di San Francesco di Sales (Salesiani di don Bosco).
Ogni clerico che viene nominato dal papa come cardinale deve comporsi uno stemma che lo rappresenti.
Uno stemma non è una semplice formalità tradizionale. Rappresenta lo più importante per una persona, una famiglia o un’istituzione, e permette la identificazione al largo dello spazio e del tempo. Sono apparse, secondo alcune ricerche, nella epoca delle Crociate, quando i cavalieri cristiani le applicavano sugli abiti, sulle bardature dei cavalli, sugli scudi e sugli stendardi, per riconoscere chiaramente gli alleati e gli avversari. Dopo, sono diversificate e sono passate alle famiglie nobiliari e anche nella Chiesa, tanto che è apparsa anche una scienza, araldica, che si occupa del loro studio.
Nella Chiesa, gli stemmi ecclesiastici sono stati standardizzati nel 1905, dal papa san Pio X, nel motu proprio “Inter multiplices cura”. Così, uno stemma ecclesiastico comprende uno scudo personale (blasone), numerosi ornamenti esterni che riprendono le insegne delle dignità a cui si riferiscono (quello del cardinale è un galero rosso con 15 nappe rosse), e un motto personale, di solito in latino, come una dichiarazione di fede. Gli elementi dello stemma fanno riferimenti al nome del titolare, alle sue origini, alla sua sede e ai simboli religiosi che richiamano messaggi teologici e valori spirituali o sintetizzano ideali di vita e programmi pastorali.
BLASONATURA
“D’argento, cappato[i] di azzurro. Nel I alla caratteristica figura di Gesù buon Pastore, presente nelle Catacombe di San Callisto, in Roma, il tutto al naturale[ii]; Nel II al monogramma MA, d’oro, timbrato[iii] da una corona dello stesso; nel III all’ancora di due uncini[iv], d’argento, cordata di rosso. Lo scudo è timbrato da un cappello[v] con cordoni e nappe di rosso. Le nappe, in numero di trenta, sono disposte quindici per parte, in cinque ordini di 1, 2, 3, 4, 5[vi], Sotto lo scudo, nella lista d’argento, il motto in lettere maiuscole di nero: “SUFFICIT TIBI GRATIA MEA”.
ESEGESI
“L’uomo medievale (…) vive in una ‘foresta di simboli’. L’ha detto sant’Agostino: il mondo si compone di ‘signa’ e di ‘res’, di segni, ossia di simboli, e di cose. Le ‘res’ che sono la vera realtà restano nascoste; l’uomo afferra solo dei segni. Il libro essenziale, la Bibbia, racchiude una struttura simbolica. A ciascun personaggio, a ciascun avvenimento del Vecchio Testamento corrisponde un personaggio, un avvenimento del Nuovo Testamento. L’uomo medievale è continuamente impegnato a ‘decifrare’, e questo rafforza la sua dipendenza dai chierici, dotti nel campo del simbolismo. Il simbolismo presiede all’arte e in particolare all’architettura in cui la chiesa è prima di tutto una struttura simbolica. S’impone in politica, dove il peso delle cerimonie simboliche come la consacrazione del re è considerevole, dove le bandiere, le armi, gli emblemi, hanno un’importanza fondamentale. Regna in letteratura, dove spesso assume la forma dell’allegoria”[vii].
Gesti e simboli rimandano, quindi, a qualche cosa di più profondo: a un messaggio, a un valore, a un’idea che oltrepassa il segno stesso.
“Nella vita umana segni e simboli occupano un posto importante. In quanto essere corporale e spirituale insieme, l’uomo esprime e percepisce le realtà spirituali attraverso segni e simboli materiali. In quanto essere sociale, l’uomo ha bisogno di segni e simboli per comunicare con gli altri per mezzo del linguaggio, di gesti, di azioni. La stessa cosa avviene nella sua relazione con Dio”[viii].
“Il dotto e famoso araldista Goffredo di Crollalanza in Genesi e Storia del Linguaggio Blasonico (1876) tra l’altro scrive; ‘L’araldica ebbe la cavalleria per autore, il bisogno per movente, il trofeo per scopo, i tornei e le crociate per occasione, il campo di battaglia per culla, l’armatura per campo, il disegno per mezzo, il simbolo per ausiliare, il creato per materia, l’ideologia per concetto, il blasone per conseguenza. Ed aggiunge: ‘Il blasone non è l’illustrazione; come la mente non è l’anima, ma la manifestazione dell’anima”[ix].
“L’araldica è un linguaggio complesso e particolare costituito da una miriade di figure e lo stemma è un contrassegno che deve esaltare una particolare impresa, un fatto importante, un’azione da perpetuare.
Questa scienza documentaria della storia dapprima era riservata ai cavalieri ed ai partecipanti ai fatti d’armi, sia guerreschi che sportivi, che si rendevano riconoscibili grazie allo stemma, posto sullo scudo, sull’elmo, sulla bandiera e anche sulla gualdrappa, rappresentante l’unico modo per distinguersi gli uni dagli altri.
L’araldica dei cavalieri venne quasi subito imitata dalla Chiesa, anche se gli enti ecclesiastici in periodo pre-araldico avevano già propri segni distintivi, tanto che al sorgere dell’araldica, nel secolo XII, tali figure assunsero i colori e l’aspetto propri di quella simbologia.
L’araldica ecclesiastica al nostro tempo è viva, attuale e largamente utilizzata. Per un prelato, tuttavia, l’uso di uno stemma deve oggi essere definito quale simbolo, figura allegorica, espressione grafica, sintesi e messaggio del suo ministero.
Occorre ricordare che agli ecclesiastici fu sempre vietato l’esercizio della milizia e il porto delle armi e per tale motivo non si sarebbe dovuto adottare il termine ‘scudo’ o ‘arme’ propri dell’araldica; tuttavia va detto che sino a tempi recenti gli ecclesiastici usavano il loro stemma di famiglia, molto spesso privo di qualunque simbologia religiosa.
La stessa simbologia della Chiesa Romana è attinta dal Vangelo ed è rappresentata dalle chiavi consegnate da Cristo all’apostolo Pietro.
L’araldica ecclesiastica al nostro tempo è viva, attuale e largamente utilizzata. Per un porporato, l’uso di uno stemma deve oggi essere definito quale simbolo, figura allegorica, espressione grafica, sintesi e messaggio del suo ministero”[x].
Nel primo periodo gli stemmi ecclesiastici risultavano con lo scudo timbrato dalla mitria con le infule svolazzanti; con il passare del tempo si consoliderà, invece, alla sommità dello scudo il cappello prelatizio con i cordoni e i vari ordini di nappe o fiocchi, di diverso numero secondo la dignità, il tutto di verde se vescovi, arcivescovi e patriarchi, il tutto di rosso se cardinali di Santa Romana Chiesa.
Annotiamo, inoltre, che con “L’Istruzione sulle vesti, i titoli e gli stemmi dei cardinali, dei vescovi e dei prelati inferiori” del 31 marzo 1969, a firma del cardinale segretario di Stato Amleto Cicognani, all’art. 28 si recita testualmente: “Ai cardinali e ai vescovi è permesso l’uso dello stemma. La configurazione di tale stemma dovrà essere conforme alle norme che regolano l’araldica e risultare opportunamente semplice e chiaro. Dallo stemma si tolgono sia il pastorale che la mitra”[xi].
Nel successivo art. 29 si precisa che ai cardinali è permesso di far apporre il proprio stemma sulla facciata della chiesa che è attribuita loro come titolo o diaconia.
Gli eccellentissimi e reverendissimi vescovi timbrano, infatti, lo scudo, accollato ad una croce astile semplice (a una traversa), d’oro, trifogliata, posta in palo, con il cappello, cordoni e nappe di verde. I fiocchi in numero di dodici sono disposti sei per parte, in tre ordini di 1, 2, 3.
Gli eccellentissimi e reverendissimi arcivescovi timbrano lo scudo, accollato ad una croce astile patriarcale d’oro, trifogliata, posta in palo, con il cappello, cordoni e nappe di verde. I fiocchi, in numero di venti, sono disposti dieci per parte, in quattro ordini di 1, 2, 3, 4.
Gli eccellentissimi e reverendissimi patriarchi timbrano lo scudo, accollato ad una croce astile patriarcale d’oro, trifogliata, posta in palo, con il cappello, cordoni e nappe di verde. I fiocchi, in numero di trenta, sono disposti quindici per parte, in cinque ordini di 1, 2, 3, 4, 5[xii].
Gli eminentissimi e reverendissimi signori cardinali di Santa Romana Chiesa timbrano lo scudo, accollato ad una croce astile patriarcale d’oro, trifogliata, posta in palo, con il cappello, cordoni e nappe di rosso. I fiocchi in numero di trenta sono disposti quindici per parte, in cinque ordini di 1, 2, 3, 4, 5.
L’origine e l’uso dei cappelli di verde, per i patriarchi, arcivescovi e vescovi, si vuole derivato dalla Spagna, dove, nel Medioevo, i prelati usavano un cappello di verde. Per tale motivo gli scudi dei vescovi, arcivescovi e patriarchi risultano timbrati con un cappello di verde.
Nel 1245, nel corso del Concilio di Lione, il papa Innocenzo IV (1243-1254) concesse ai cardinali un cappello di rosso, quale particolare distintivo d’onore e di riconoscimento tra gli altri prelati, da usarsi nelle cavalcate in città. Lo prescrisse di rosso per ammonirli a essere sempre pronti a spargere il proprio sangue per difendere la libertà della Chiesa e del popolo cristiano. Ed è per questo motivo che dal XIII secolo i cardinali timbrano il loro scudo con un cappello di rosso, ornato di cordoni e di nappe dello stesso colore.
Infine, l’eminentissimo e reverendissimo signor cardinale camerlengo di Santa Romana Chiesa porta lo scudo con lo stesso cappello degli altri cardinali, ma timbrato dal gonfalone papale, durante munere, ossia durante la sede vacante apostolica. Il gonfalone papale o stendardo papale, chiamato anche basilica, è a forma di ombrellone a gheroni rossi e gialli con i pendenti tagliati a vajo e di colori contrastati, sostenuto da un’asta a forma di lancia coll’arresto ed è attraversata dalle chiavi pontificie una d’oro e l’altra d’argento, decussate, addossate, con gli ingegni rivolti verso l’alto, legate da nastro di rosso.
Gli stessi colori di verde o di rosso vanno usati, altresì, nell’inchiostro dei sigilli e negli stemmi riportati negli atti, quest’ultimi con i previsti segni convenzionali indicanti gli smalti.
La blasonatura – descrizione araldica – dello stemma del cardinale Ángel FERNÁNDEZ ARTIME SdB non porta lo scudo accollato a una croce astile, d’oro, posta in palo, perché non è vescovo. Verrà consacrato nell’ordine episcopale, il prossimo anno, dopo la cessazione dal servizio di Rettor Maggiore dei Salesiani di don Bosco e in tale momento al suo scudo verrà accollata una croce astile, posta in palo.
L’Antico ed il Nuovo Testamento, la Patristica, i legendaria dei Santi, la Liturgia hanno offerto, nei secoli, alla Chiesa i temi più svariati per i suoi simboli, destinati a divenire figure araldiche.
Quasi sempre tali simboli alludono a compiti pastorali o di apostolato degli istituti ecclesiastici, sia secolari che regolari, oppure tendono ad indicare la missione del clero, richiamano antiche tradizioni di culto, memorie di santi patroni, pie devozioni locali.
GLI SMALTI
Una delle norme fondamentali che regola l’araldica asserisce che chi ha meno ha più, con riguardo alla composizione degli smalti, figure e positure dello scudo.
E l’arme che ora andremo a esaminare è composta dai metalli oro e argento e dai colori d’azzurro e di rosso.
Cercare il proprio stemma, quindi, quello vero, da poter innalzare come vessillo, con il quale segnare le proprie carte, comprenderne compiutamente i simboli, non è, in qualche modo, cercare sé stessi, la propria immagine, la propria dignità?
Ecco come un atto, che potrebbe essere letto solo formalmente, può acquisire invece un significato simbolico e fortemente pregnante.
D’oro, d’argento, d’azzurro e di rosso, quindi, sono gli smalti che figurano nello stemma dell’em.mo cardinale Ángel FERNÁNDEZ ARTIME SdB., ma quali simboli racchiudono e sprigionano tali smalti, quali messaggi ne derivano per l’uomo, spesso frastornato, giunto, oramai, al XXI secolo?
I “metalli”, di oro e d’argento, araldicamente rappresentano e ricordano le antiche armature dei cavalieri che, secondo il rispettivo grado di nobiltà, erano appunto dorate o argentate; l’oro, inoltre, è simbolo della regalità divina, mentre l’argento allude a Maria. Il “colore” d’azzurro ricorda il mare attraversato dai crociati per portarsi in Terra Santa, mentre il di rosso che era considerato, da molti araldisti, il primo fra i colori dell’arme, il sangue vivo versato dai crociati.
Addentrandoci più specificatamente nel simbolismo araldico degli “smalti”, ricordiamo che fra i “metalli”, l’oro rappresenta la Fede fra le virtù, il sole fra i pianeti, il leone nei segni zodiacali, luglio fra i mesi, la domenica fra i giorni della settimana, il topazio fra le pietre preziose, l’adolescenza sino ai vent’anni fra le età dell’uomo, il girasole fra i fiori, il sette fra i numeri e se stesso fra i metalli; l’argento rappresenta la Speranza fra le virtù, la luna fra i pianeti, il cancro nei segni zodiacali, giugno fra i mesi, il lunedì fra i giorni della settimana, la perla fra le pietre preziose, l’acqua fra gli elementi, l’infanzia sino a sette anni fra le età dell’uomo, il flemmatico fra i temperamenti, il giglio fra i fiori, il due fra i numeri e se stesso fra i metalli.
Fra i “colori”, l’azzurro, simboleggia la Giustizia fra le virtù, Giove fra i pianeti, il toro e la bilancia nei segni zodiacali, aprile e settembre fra i mesi, il martedì fra i giorni della settimana, lo zaffiro fra le pietre preziose, l’aria fra gli elementi, l’estate fra le stagioni, la fanciullezza sino ai quindici anni fra le età dell’uomo, il collerico fra i temperamenti, la rosa fra i fiori, il sei fra i numeri e lo stagno fra i metalli, mentre il di rosso, la Carità fra le virtù teologali, Marte fra i pianeti, l’ariete e lo scorpione nei segni zodiacali, marzo e ottobre fra i mesi, il mercoledì fra i giorni della settimana, il rubino fra le pietre preziose, il fuoco fra gli elementi, l’autunno fra le stagioni, la virilità sino a cinquant’anni fra le età dell’uomo, il sanguigno fra i temperamenti, il garofano fra i fiori, il tre fra i numeri e il rame fra i metalli.
Il rosso: “è anche un ricordo dell’Oriente e delle spedizioni d’oltremare, come pure dimostra giustizia, crudeltà e collera. Ignescunt irae, disse Virgilio. Finalmente, siccome dagli antichi era consacrato a Marte, significa slanci d’animo intrepido, grandioso e forte. Gli Spagnoli chiamano il campo rosso ‘sangriento’, ossia sanguinoso, perché richiama alla memoria le battaglie sostenute contro i Mori. Un nome analogo lo troviamo in Germania nel blütige Fahne, vexillum, cruentum, campo tutto rosso senza alcuna figura, che indica i diritti di regalìa, e si trova nell’armi di Prussia, d’Anhalt, ecc. Il rosso è coll’azzurro uno dei due colori più usati nel blasone; ma più frequentemente si trova nelle armi di famiglie borgognone, normanne, guascone, brettone, spagnole, inglesi, italiane e polacche… Nelle bandiere il rosso rappresenta ardire e valore, e pare sia stato adottato in principio dagli adoratori del fuoco”[xiii].
Fra i “colori”, “al naturale” è “una figura riprodotta con il suo colore naturale (ossia come si presenta in natura) e non come uno smalto araldico”[xiv].
Ci preme evidenziare che fu necessario, altresì, creare dei segni convenzionali per comprendere e individuare gli “smalti” dello scudo, quando lo stemma risulta riprodotto nei sigilli e nelle stampe in bianco e nero. Così gli araldisti, nel tempo, usarono vari sistemi; ad esempio, scrissero nei vari campi occupati dagli smalti, l’iniziale della prima lettera corrispondente al colore dello smalto, oppure individuarono i colori con l’iscrivere le prime sette lettere dell’alfabeto o, ancora riprodussero, sempre nei campi dello smalto, i primi sette numeri cardinali.
Nel XVII secolo, l’araldista francese Vulson de la Colombière propose, invece, dei particolari segni convenzionali per riconoscere il colore degli smalti negli scudi riprodotti in bianco e nero. L’araldista padre Silvestro di Pietrasanta della Compagnia di Gesù, per primo, ne fece uso nella sua opera Tesserae gentilitiae ex legibus fecialium descriptae, diffondendone, così, la conoscenza e l’uso.
Tale sistema di classificazione, tuttora usato, identifica il rosso con fitte linee perpendicolari, l’azzurro con orizzontali, il verde con diagonali da sinistra a destra, il porpora con diagonali da destra a sinistra, il nero con orizzontali e verticali incrociate, mentre l’oro si rende punteggiato e l’argento senza tratteggio.
Per rappresentare il colore “al naturale” alcuni araldisti prevedono altri segni convenzionali, ma intendiamo sposare la tesi dell’araldista Goffredo di Crollalanza dove, per il colore “al naturale”, dopo aver ricordato che si può porre sopra metallo e sopra colore indifferentemente, senza ledere la legge della sovrapposizione degli smalti, chiarisce che si esprime[xv] nei disegni lasciando in bianco il pezzo e ombreggiando la figura nei luoghi acconci.
Dello stesso avviso è stato anche l’insigne araldista arcivescovo mons. Bruno Bernard Heim, che negli stemmi pontificali dei Papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo I da Lui ideati, in quelli riprodotti in bianco e nero, nel capo patriarcale di Venezia raffigura il leone marciano senza alcun segno convenzionale, alla presenza di un capo tra i più famosi e belli.
LE FIGURE
Gesù buon Pastore
La figura di Gesù buon Pastore risponde a un’aspirazione profonda dell’uomo antico. Gli ebrei vedevano in Dio il vero e proprio pastore che guida il suo popolo. Mosè, a sua volta, aveva ricevuto il compito di essere per il suo popolo pastore e guida. I Greci conoscevano l’immagine del pastore che sta in un grande giardino e porta una pecora sulle spalle. Il giardino ricorda il paradiso.
I Greci associano al pastore la loro nostalgia di un mondo puro, non corrotto. In molte culture, il pastore è una figura paterna, di padre accorto e premuroso nei confronti dei figli, un’immagine della sollecitudine paterna di Dio per gli uomini.
I primi cristiani fanno propria l’aspirazione di Israele e della Grecia. Gesù è, come Dio, il pastore che conduce il suo popolo alla vita. I cristiani di cultura ellenista associano la figura del buon pastore a quella dì Orfeo, il cantore divino. Il suo canto addomesticava le bestie feroci e risuscitava i morti. Orfeo è solitamente rappresentato all’interno di un paesaggio idillico, circondato da pecore e leoni.
Per i cristiani ellenisti Orfeo è una figura di Gesù. Gesù è il cantore divino, che con le sue parole rende pacifico ciò che di selvaggio, di feroce c’è in noi e fa rivivere ciò che è morto. Gesù, presentandosi nel vangelo di Giovanni come il buon pastore, realizza le immagini archetipiche dì salvezza racchiuse nell’animo umano sotto le immagini del pastore. Tale figura, nello scudo, proprio per la sua valenza, viene caricata nella positura principale.
Monogramma di Maria Ausiliatrice
Tale monogramma, MA, timbrato da una corona, il tutto d’oro, simboleggia Maria AUSILIATRICE, la Madonna di don Bosco. Dopo il nome di Gesù, non figura, infatti, nome più dolce, più potente, più consolante che quello di Maria; nome dinanzi a cui s’inchinano riverenti gli Angeli, la terra si allieta, l’inferno trema.
San Giovanni Bosco un giorno confidò ad uno dei suoi primi Salesiani, don Giovanni Cagliero, grande missionario in America Latina e futuro cardinale che la: “La Madonna vuole che la onoriamo sotto il titolo di Ausiliatrice”, aggiungendo che: “I tempi corrono così tristi che abbiamo bisogno che la Vergine Santa ci aiuti a conservare e difendere la fede cristiana”.
Tale titolo mariano, in verità, esisteva giù dal sec. XVI nelle Litanie lauretane e il papa Pio VII istituì la festa di Maria Ausiliatrice nel 1814 e la fissò per il 24 maggio, quale segno di ringraziamento, per il ritorno a Roma, in tal giorno, acclamato dal popolo, dopo l’esilio decretato da Napoleone. Ma é proprio grazie a don Bosco e alla costruzione del Santuario di Maria Ausiliatrice, in Torino Valdocco – voluto dalla stessa Madonna, che apparsa in una visione al Santo, indicò di voler essere onorata nel luogo esatto dove subirono la morte i primi martiri torinesi Avventore, Ottavio e Solutore, soldati cristiani della Legione Tebea – che il titolo di Ausiliatrice tornò attuale nella Chiesa. Don Lemoyne, segretario particolare del Santo, nella sua monumentale biografia scrive testualmente: “Ciò che appare chiaro e inconfutabile è che fra don Bosco e la Madonna c’era di sicuro un patto. Tutto il suo gigantesco lavoro fu fatto non solo in collaborazione, ma addirittura in associazione con la Vergine”.
Don Bosco, di conseguenza, raccomandava ai suoi Salesiani, di diffondere la devozione alla Madonna, con il titolo di Ausiliatrice, in qualunque parte del mondo si trovassero. Ma don Bosco non lasciava alla sola devozione spontanea il culto a Maria Ausiliatrice; le dava stabilità con un’Associazione che da Lei prendeva nome. I testimoni diretti hanno visto nell’Associazione dei Devoti di Maria Ausiliatrice, una delle iniziative più care a don Bosco e di più vasta risonanza, dopo quella delle due congregazioni religiose (Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice) e dell’Associazione dei Cooperatori.
Infatti: “non è Don Bosco che ha scelto Maria; è Maria che, mandata dal suo Figlio, ha preso l’iniziativa di scegliere Don Bosco e di fondare per mezzo suo l’opera salesiana, che è opera sua, ‘affare suo’, per sempre”[xvi].
L’ancora
L’ancora ricorda, in primo luogo, che il cardinale Ángel FERNÁNDEZ ARTIME SdB, è figlio di un pescatore del mare di Spagna.
Doveroso ricordare, poi, che “Lo stemma salesiano risulta un condensato di stimoli essenziali per qualificare ogni vero figlio di don Bosco. San Giovanni Bosco volle rappresentate nello scudo anche le virtù teologali: per la Fede, la stella; per la Speranza, l’ancora e per la Carità, il cuore. Potrebbe sembrare assente, sempre nello stemma salesiano, l’imprescindibile presenza di Maria Ausiliatrice da cui – diceva don Bosco – tutto ciò che è salesiano deriva. Ma lo stesso fondatore, e tutti i primi confratelli, identificarono sempre ne simboli dell’ancora, della stella e del cuore, anche il riferimento a Gesù e a sua Madre; e questo è un altro aspetto della densità significativa che lo stemma racchiude”[xvii].
Infatti, la vita e l’azione del salesiano sono espressione: della sua fede, la stella raggiante, della sua speranza, la grande ancora e della sua carità pastorale, il cuore infiammato.
L’ancora, in araldica, invece, simboleggia la costanza[xviii]. “Strumento usato nella navigazione mediterranea, al quale già nell’antichità era attribuita importanza come simbolo del dio del mare. L’ancora prometteva stabilità e sicurezza e perciò divenne il simbolo di fede e speranza. Impiegata in un primo tempo nelle immagini sepolcrali precristiane come indicazione professionale e come contrassegno delle tombe di marinai, per la sua forma a croce, essa divenne nel protocristianesimo un simbolo mascherato della redenzione”[xix].
Come l’uomo, così il simbolo è anche ciò che è stato per essere autenticamente ciò che sarà.
Necessita quindi fare memoria e speranza di questa sorgente ricchissima e inesausta, a cui è possibile attingere ancora per il nostro oggi.
Giorgio ALDRIGHETTI
Blasonatura ed esegesi a cura dell’araldista Giorgio Aldrighetti di Chioggia (Venezia), socio ordinario dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano. Miniature a cura dell’araldista Enzo Parrino di Monterotondo (Roma).
[i] Partizione araldica costituita da uno scudo diviso in tre sezioni, di due diversi smalti, ottenute da due linee curve che, dal punto di mezzo del lato superiore dello scudo, raggiungono i punti mediani dei due lembi laterali dello scudo. (L. Caratti di Valfrei, Dizionario di Araldica, Milano 1997, p. 50. voce Cappato.
[ii] “È una figura riprodotta con il suo colore naturale (ossia come si presenta in natura) e non come uno smalto araldico (Ibidem, p. 18, voce al naturale).
[iii] “Sono tutte le diverse ornamentazioni esterne di uno stemma, poste al di sopra di uno scudo”. In questo caso. sul monogramma). (Ibidem, p: 203, voce timbro).
[iv] “Sono i ramponi dell’ancora”, (La Caratti di Valfrei, Dizionario di Araldica, cit., p. 211, voce uncini).
[v] Cappello prelatizio, segno di dignità ecclesiastica, rappresentato con calotta emisferica e la tesa rotonda piana caratteristiche del galero, copricapo a larghe falde usato dal tardo medioevo fino a tempi recenti da cardinali e altri prelati. Usato come ornamento esterno non liturgico dello scudo. Assume colori diversi, ed è ornato di cordoni dai quali pendono uno o più fiocchi ordinariamente pendenti a piramide su ambio i lati; la dignità ed il ruolo rivestiti dal titolare si desumono dal loro numero e dagli smalti dell’insieme. (A. Cordero Lanza di Montezemolo-A. Pompili, Manuale di Araldica Ecclesiastica, cit., p. 116, voce Cappello prelatizio)
[vi] Gli eminentissimi e reverendissimi signori cardinali di Santa Romana Chiesa timbrano lo scudo – accollato ad una croce astile d’oro, trifogliata, posta in palo, se hanno la consacrazione episcopale – con il cappello, cordoni e nappe di rosso. I fiocchi in numero di trenta sono disposti quindici per parte, in cinque ordini di 1, 2, 3, 4, 5.
[vii] Jacques Le Goff, L’uomo medievale, Bari 1994, p. 34.
[viii] Catechismo della Chiesa Cattolica, Città del Vaticano 1999, p. 335.
[ix] A. Cordero Lanza di Montezemolo – A. Pompili, Manuale di Araldica Ecclesiastica, cit., p. 18.
[x] P. F. degli Uberti, Gli Stemmi Araldici dei Papi degli Anni Santi, Ed. Piemme, s. d
[xi] da L’Osservatore Romano, 31 marzo 1969.
[xii] L’araldista Sua Ecc.za Rev.ma mons. Bruno Bernard Heim per lo stemma patriarcale così recita: “I patriarchi ornano il loro scudo con un cappello di color verde dal quale scendono due cordoni pure verdi che terminano in quindici fiocchi verdi per ciascun lato”. (B. B. Heim, L’Araldica della Chiesa Cattolica, origini, usi, legislazione, Città del Vaticano 2000, p. 106.).
[xiii] G. Crollalanza (di), Enciclopedia araldico-cavalleresca, Pisa 1886, pp. 516-517, voce Rosso.
[xiv] L Caratti di Valfrei, Dizionario di Araldica, Milano 1997, p. 18, voce al naturale.
[xv] A. Cordero Lanza di Montezemolo – A. Pompili, Manuale di Araldica Ecclesiastica, cit., p. 28, voce Al naturale.
[xvi] Cooperatori di Dio, Roma 1976-1977, Edizioni Cooperatori, p. 69
[xvii] G. Aldrighetti, Il bosco e le rose. Il nostro stemma. Bollettino Salesiano, dicembre 2018.
[xviii] L Caratti di Valfrei, Dizionario di Araldica, cit., p. 21, voce Ancora.
[xix] H. Biedermann, Enciclopedia dei simboli, Milano 1989, p.30, voce Ancora.