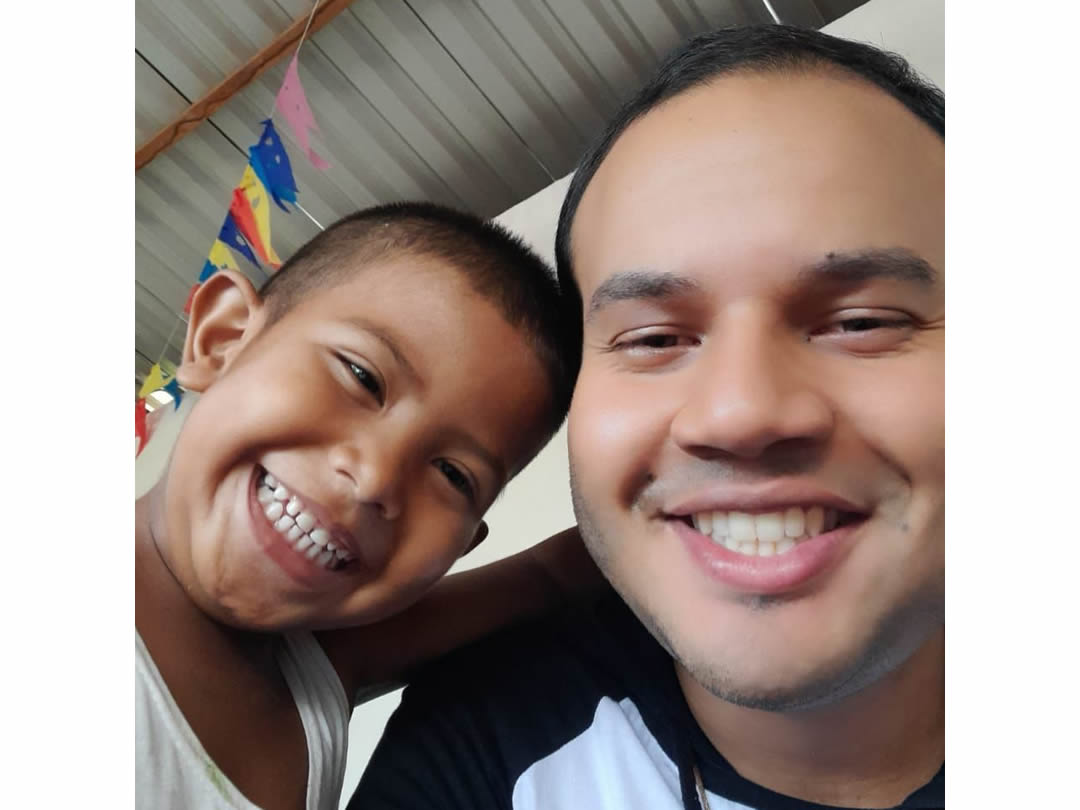«CREDETTI, PROMISI, GUARII!»
Artemide Zatti: Vangelo della Vocazione e Chiesa della Cura
«Il
mosaico dei nostri santi e beati, pur essendo abbastanza ricco quanto
a rappresentatività -Fondatore, Cofondatrice, Rettori
Maggiori, missionari, martiri, sacerdoti, giovani – era ancora privo
del tassello prezioso della figura di un coadiutore. Ora anche questo
si sta realizzando».
Così
don Juan Edmundo Vecchi, ottavo Successore di don Bosco, cominciava
la sua lettera in occasione della beatificazione di Artemide Zatti.
Se
al “mosaico dei nostri santi” mancava una tessera, oggi
questo mosaico ha una lucentezza del tutto particolare perché,
tra poche settimane, ci sarà dato di vivere un grande dono del
Signore: vedere uno dei figli di Don Bosco, coadiutore salesiano,
emigrato italiano in Argentina e infermiere, canonizzato da Papa
Francesco il prossimo 9 ottobre 2022.
Artemide
Zatti sarà, dunque, il primo
santo salesiano non martire ad essere canonizzato.
Senza dubbio la canonizzazione del primo santo salesiano e di un
salesiano coadiutore dà e darà un tocco di completezza
alla serie di modelli di spiritualità salesiana, che la Chiesa
dichiara ufficialmente tali.
Riporto
la bellissima testimonianza personale, piena di profondità
spirituale e di fede, resa da Artemide Zatti nel 1915 a Viedma, in
occasione dell’inaugurazione di un monumento funerario posto
sulla tomba del Padre Evasio Garrone (1861-1911), salesiano
missionario benemerito e considerato da Artemide insigne benefattore.
«Se
io sto bene, sono sano e in condizione di fare un po’ di bene
al mio prossimo infermo, lo debbo al Padre Garrone, Dottore, che
vedendo peggiorare di giorno in giorno la mia salute, essendo io
affetto da tubercolosi con frequenti emottisi, mi disse decisamente
che, se non volevo finire come molti altri, facessi una promessa a
Maria Ausiliatrice di rimanere sempre al fianco suo, aiutandolo nella
cura degli infermi, che egli, confidando in Maria, m’avrebbe
guarito.
CREDETTI,
perché sapevo per fama che Maria Ausiliatrice lo aiutava in
modo visibile.
PROMISI,
perché sempre fu mio desiderio essere d’aiuto in
qualcosa al mio prossimo.
E,
avendo Dio ascoltato il suo servo, GUARII.
[Firmato]
Artemide Zatti».
Vediamo
che la vita salesiana di Artemide Zatti, secondo questa
testimonianza, si fonda su tre verbi che ne testimoniano la solidità
generosa e confidente. Per valorizzare il dono della santità
di questo grande salesiano coadiutore, vorremmo meditare su questi
tre verbi e sui loro straordinari frutti di bene, perché
tocchino in profondità i desideri, i sogni, gli impegni della
nostra Congregazione e di ciascuno di noi e promuovano in tutti una
rinnovata e feconda fedeltà al carisma di don Bosco.
Profilo
di Artemide Zatti
Artemide
Zatti nasce a Boretto (Reggio Emilia) il 12 dicembre 1880 da Albina
Vecchi e Luigi Zatti. La famiglia contadina lo educa ad una vita
povera e laboriosa, illuminata da una fede semplice, schietta e
robusta, che guida e nutre la vita.
A
nove anni Artemide, per contribuire all’economia familiare,
lavora come bracciante presso una famiglia benestante.
Nel
1897 gli Zatti emigrano in Argentina e si stabiliscono a Bahia
Blanca. Artemide giunge in questa Città all’età
di diciassette anni e nell’ambiente familiare impara presto ad
affrontare le fatiche e le responsabilità del lavoro. Trova
lavoro in una fabbrica di mattoni e, nello stesso tempo, coltiva e
matura una profonda relazione con Dio, sotto la guida del salesiano
don Carlo Cavalli, suo Parroco e Direttore spirituale. Artemide trova
in lui un vero amico, un confessore saggio e un autentico ed esperto
direttore spirituale, che lo forma al ritmo quotidiano della
preghiera e alla vita sacramentale settimanale. Con don Cavalli
stabilisce un rapporto spirituale e di collaborazione.
Nella biblioteca del suo parroco ha la possibilità di leggere
la biografia di Don Bosco e ne rimane affascinato. Fu
il vero inizio della sua vocazione salesiana.
Nel
1900, ormai ventenne, Artemide, invitato da don Cavalli, chiede di
entrare nell’aspirantato salesiano di Bernal, località
vicina a Buenos Aires.
Nel
1902, ormai prossimo all’ingresso in noviziato, Artemide
contrae però la tubercolosi. Racconta don Vecchi nella sua
lettera: «Sicuri della sua responsabilità, i superiori
gli affidarono l’assistenza di un giovane sacerdote malato di
tubercolosi. Zatti svolse con generosità l’incarico, ma
dopo denunziò la stessa malattia».
Gravemente
malato, fa ritorno
a Bahía Blanca
e don Cavalli lo invia a Viedma, affidandolo alle cure del salesiano
don Evasio Garrone, competente – grazie a lunga esperienza –
nell’arte medica e direttore dell’ospedale San José
fondato da mons. Cagliero.
Trovo
molto significativo ricordare che Artemide a Viedma incontra Zefirino
Namuncurá-oggi beato-proveniente da Buenos Aires e come lui
affetto da tubercolosi. I due, pur con età diversa, vivono in
cordiale amichevole rapporto, finché Zefferino parte nel 1904
per l’Italia con Mons. Giovanni Cagliero.
Dopo
due anni di cure a Viedma con risultati insoddisfacenti, don Garrone
invita Artemide a chiedere la guarigione per intercessione della
Vergine Santa, facendo voto di dedicare tutta la vita alla cura dei
malati. Formulato il voto con viva fede, Artemide ottiene la
guarigione e, nel 1906, inizia il noviziato.
Per
i rischi associati alla pregressa condizione di salute, Artemide deve
rinunciare al proposito di diventare sacerdote e professa come
coadiutore tra i Salesiani di don Bosco l’11 gennaio 1908.
Questo fatto comporta per Artemide una grande crescita nella fede.
Infatti, egli non abbandona il desiderio di essere salesiano prete e
continua a pensare alla vocazione sacerdotale nella Congregazione
Salesiana, soprattutto quando la salute sembrava migliorare. Perciò
«è commovente constatare l’attaccamento
incrollabile alla propria vocazione, manifestato anche quando la
malattia sembrava precludere assolutamente questo cammino. Leggiamo,
ad esempio, quello che scrive ai suoi il 7 agosto 1902: “Vi fò
sapere che non solo era mio desiderio, ma anche dei miei Superiori di
mettermi il sacro abito; ma c’è un articolo della Santa
Regola che dice di non poter ricevere l’abito uno che abbia la
più piccola cosa rispetto alla salute. Così è
che se Dio non mi trovò degno dell’abito finora, confido
nelle vostre orazioni di sanare presto e così appagare i miei
desideri”».
Ma
alla fine i Superiori, date tutte le circostanze di malattia e anche
l’età (23-24 anni) devono proporre a Zatti di professare
come salesiano coadiutore. È certo che «era la donazione
totale a Dio nella vita salesiana cui Artemide aspirava in primo
luogo».
Anche
su questo punto decisivo nella sua vita, Zatti compie un camino di
maturità. Leggiamo ancora nella lettera di don Vecchi:
«Sacerdote? Coadiutore? Diceva egli stesso ad un confratello:
“Si può servire Dio sia come sacerdote sia come
coadiutore: davanti a Dio una cosa vale tanto come l’altra,
purché la si viva come una vocazione con amore”».
L’11
febbraio 1911 emette i voti perpetui e, nello stesso anno, dopo la
morte di don Garrone, gli subentra, dapprima come incaricato della
farmacia annessa all’ospedale San José di Viedma, e poi
– dal 1915 – come responsabile dello stesso ospedale.
Ospedale e farmacia diverranno il campo di lavoro di Artemide.
Così,
dal 1915, per 25 anni, con grande energia, sacrificio e
professionalità Zatti sarà l’anima dell’ospedale
che però, nel 1941, dovrà essere demolito: i superiori
salesiani decidono di utilizzare il terreno fino ad allora occupato
dalla struttura sanitaria per la costruzione della sede vescovile.
Artemide soffre intensamente al pensiero della demolizione, ma in
spirito di obbedienza accetta la decisione e trasferisce gli ammalati
negli ambienti della Scuola Agricola Sant’Isidro dove crea una
nuova struttura per la cura e l’assistenza di infermi e poveri.
Dopo
altri anni di intenso servizio, ormai esonerato dalle responsabilità
dell’amministrazione sanitaria, nel 1950, a seguito di una
caduta durante un lavoro di riparazione, gli esami clinici gli
riscontrano un tumore al fegato per il quale sono vane le cure.
Accoglie e vive con consapevolezza l’evoluzione della malattia.
Di fatto, egli stesso prepara per il medico il certificato della
propria morte! Non sono poche le sofferenze, ma trascorre gli ultimi
mesi nell’attesa del momento finale preparato per l’incontro
con il Signore. Lui stesso dice: «Cinquant’anni fa sono
venuto qui per morire e sono arrivato fino a questo momento, che cosa
posso desiderare di più? D’altra parte, ho trascorso
tutta la vita preparandomi per questo momento…».
La
morte sopravviene il 15 marzo 1951 e la diffusione della notizia
mobilita la popolazione di tutta Viedma per un tributo di gratitudine
a questo salesiano che ha dedicato l’intera vita ai malati,
soprattutto più poveri. Di fatto, “tutta Viedma salutò
il “parente
di tutti i poveri”,
come lo chiamavano da tempo; colui che era sempre disponibile per
accogliere i malati speciali e la gente che veniva dalla lontana
campagna; colui che poteva entrare nella più ambigua delle
case a qualsiasi ora del giorno o della notte, senza che alcuno
potesse insinuare il minimo sospetto su di lui; colui che, pur
essendo sempre “in rosso”, aveva mantenuto un rapporto
singolare con le istituzioni finanziarie della città, sempre
aperte all’amicizia ed alla collaborazione generosa con coloro
che componevano il corpo medico della cittadina».
I
funerali, con l’imponente afflusso di popolo, confermano la
fama di santità che circonda Artemide Zatti e che sollecita
l’apertura a Viedma del processo diocesano (22 marzo 1980). Il
7 luglio 1997 Zatti viene dichiarato Venerabile e il 14 aprile 2002 è
proclamato Beato da San Giovanni Paolo II.
La
pedagogia di Dio nei suoi santi
Per
accostare la figura di Artemide Zatti è preziosa la guida di
un principio teologico, denso di significato e ripetuto da Hans Urs
von Balthasar:
«Soltanto
l’immagine [di Gesù] che lo Spirito presenta alla Chiesa
ha saputo, lungo millenni di storia, trasformare uomini peccatori in
santi. Proprio in base a questo criterio della potenza di
trasformazione si dovrebbe misurare il valore di un’interpretazione
di Gesù che pretenda trasmetterci una conoscenza di Lui».
Con
queste parole, Balthasar rimarca un’evidenza che ha sempre
accompagnato la storia della Chiesa: l’azione dello Spirito si
manifesta come potenza di trasformazione della vita umana, a
testimonianza della perenne attualità e vitalità del
Vangelo. In questo modo la buona notizia di Gesù continua a
vivere e diffondersi secondo la regola dell’Incarnazione e,
specie nella carne e nella vita dei santi, per il loro profondo
consentire allo Spirito, la Pasqua sfolgora nell’attualità
storica di qui
ed ora
sempre nuovi, ove maturano prodigi che confermano la fede della
Chiesa.
I
santi sono allora realizzazioni dello Spirito che offrono, con la
semplicità di una vita trasfigurata, lineamenti precisi del
Figlio, donati dal Padre alla fatica del mondo, nell’attualità
di un tempo e nella prossimità di luoghi bisognosi di salvezza
e di speranza.
Se
Dio guida la sua Chiesa attraverso la vita obbediente dei suoi figli
più docili e audaci, nella storia di ciascuno di loro devono
anzitutto brillare riflessi di Vangelo che trasformano una
feriale biografia in agiografia
e poi si debbono riconoscere semi pasquali, capaci di innescare
rinnovati cammini ecclesiali nel popolo di Dio.
Artemide
Zatti conferma questa regola della santità: l’agiografia
è luce dello Spirito sprigionata dalla semplicità della
sua biografia, tanto convincente perché abitata in pienezza
d’umanità, e tanto sorprendente da rendere visibili «un
nuovo
cielo e una nuova terra» (Ap
21,1); così i semi pasquali, regalati dalla vita di questo
salesiano coadiutore al campo del mondo, hanno trasformato luoghi di
sofferenza – gli ospedali di San José e di Sant’Isidro
– in vivai della speranza cristiana straordinariamente
irradianti. «Si è trattato di un’attiva presenza
nel sociale, tutta animata dalla carità di Cristo che lo
spingeva interiormente».
È
possibile allora meditare sul dono che lo Spirito fa al mondo, alla
Chiesa, alla Famiglia Salesiana con la santità di Zatti,
sostando dapprima sulla luminosità della sua biografia –
un Vangelo, pienamente incarnato, della vocazione, della confidenza e
della dedizione – per considerare poi la forza pasquale del suo
apostolato che ha edificato, nei suoi ospedali, la chiesa della cura,
della prossimità, della salvezza, della corredenzione, per
nutrire la fede del popolo di Dio.
Se
vogliamo esprimere in modo sintetico il segreto che ha ispirato e
guidato la vita, i passi, i lavori, gli impegni, la gioia, le
lacrime…, di Artemide Zatti, le parole di don Vecchi a tale
fine sono esaustive: «Al
seguito di Gesù, con Don Bosco e come Don Bosco, dovunque e
sempre».
1.
UN UOMO DI VANGELO
1.1
Il Vangelo della vocazione: «Credetti»
La
vicenda di Artemide Zatti colpisce anzitutto per la sua particolarità
vocazionale. Una vocazione luminosa perché purificata da una
misteriosa pedagogia di Dio che si dispiega nella sua vita attraverso
mediazioni e situazioni diverse e impegnative. La vita cristiana è
il respiro condiviso della famiglia di Artemide, che tutto legge
nella luce del mistero di Dio; sarà la seconda patria
argentina, raggiunta con l’emigrazione, a mostrare il
radicamento degli Zatti in una fede non comune. Il Card. Cagliero
scrive:
«I
nostri compatrioti, anche quelli che appartengono alle popolazioni
più religiose d’Italia, giunti qui pare che mutino
natura. L’amore smodato al lavoro, l’indifferenza
religiosa dominante in quei paesi, i pessimi esempi frequentissimi
[…] operano un’incredibile trasformazione nello spirito
e nel cuore dei nostri buoni contadini ed artigiani, che in cambio di
qualche scudo che guadagnano, perdono la fede, la moralità, la
religione».
La
famiglia Zatti non cederà all’influsso dell’ambiente,
segnalandosi al contrario per una pratica religiosa fervente,
schietta, coraggiosa, libera dal rispetto umano; e Artemide
continuerà a nutrire in famiglia un intenso rapporto con Dio,
sostanziato di preghiera, laboriosità, rettitudine, così
«tutto
fa credere […] che la formazione religiosa che il Servo di Dio
ricevette da fanciullo e nella prima giovinezza […] dovette
essere privilegiata e tale da spiegare gli atteggiamenti spirituali
che egli mantenne poi per tutta la vita».
L’esperienza
di Artemide riflette la discrezione luminosa della «“misura
alta” della vita cristiana ordinaria» (Novo
Millennio ineunte,
31) frutto di un esclusivo radicamento in Dio, di una fede vissuta
come obbedienza coraggiosa e irraggiante perché libera, lieta
e feconda.
Quando
il salesiano don Cavalli, parroco e guida di Artemide sui sentieri
dello Spirito, dovrà sostenerne l’orientamento
definitivo di vita, il discernimento sarà sobrio e limpido:
constaterà che la chiamata a darsi a Dio totalmente, come
sacerdote, risuona nel cuore di quel giovane in modo integro e puro,
non contaminata dalla ricerca di sé e del proprio interesse,
ma accesa dal desiderio di servire il Vangelo del Regno.
E
Dio, per la singolare disponibilità di Artemide al dono di sé,
non si limita a chiamare, ma può dilagare, con il segno
incontrovertibile della sua presenza: la croce del Figlio. Così
proprio al cuore del discernimento vocazionale di questo giovane
desideroso di diventare sacerdote si rende riconoscibile il sigillo
della predilezione di Dio: Artemide, accolto a Bernal come aspirante,
viene richiesto di un servizio rischioso, la cura di un sacerdote
malato di tubercolosi-come ricordato in precedenza. Il servizio senza
calcolo porta Artemide a contrarre a propria volta la malattia che
esigerà il sacrificio del sogno vocazionale: Zatti sarà
salesiano, ma non sacerdote.
Qui
riconosciamo la potenza del Vangelo accolta senza condizioni nella
vita dei santi; una potenza che suscita una risposta vocazionale pura
perché custodita da un cuore non solo distaccato dal male
-condizione essenziale per l’ascolto della voce di Dio-ma
capace di libertà anche rispetto al bene, condizione
essenziale di una fede rocciosa nell’Assoluto di Dio.
Camminando
nell’oscurità luminosa della fede, Artemide sacrifica il
desiderio di servire la Chiesa nella forma ministeriale del
sacerdozio, abbracciandone però l’essenza, secondo
Cristo, «il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì sé
stesso senza macchia a Dio» (Eb
9,14).
I
caratteri del vangelo della vocazione si riconoscono così,
indelebili, nella pienezza del sacrificio di sé che sigilla il
principio della vita salesiana di Zatti ben prima di coronarne la
pienezza.
E
la fedeltà alla forma laicale della vita salesiana,
abbracciata per puro amore di Dio, sarà piena e convinta,
lontana da ogni rammarico, dispiegata in un’esistenza
convincente e contenta.
Questo
è il vangelo della vocazione, la buona notizia della chiamata
di Dio riservata singolarmente a ciascuno dei suoi figli, chiamata
della quale Dio solo conosce la portata, le ragioni, la destinazione,
lo svolgimento concreto. Chiamata che si rende percepibile solo nella
corrispondenza pura dell’amore che, a propria volta «vuole
disfarsi dell’avversario più pericoloso: la propria
libertà di scelta. Ogni vero amore ha perciò la forma
interna del voto: esso si lega all’amato, a motivo dell’amore
e nello spirito dell’amore».
Il
vangelo della vocazione,
nella santità di Zatti, è il vangelo della pura fede:
la buona notizia del respiro sano del cuore che assapora la libertà
nell’obbedienza al disegno di Dio, custode del mistero di ogni
vita chiamata ad essere tralcio fecondo della vera Vite, affidata
alla sapienza dell’«Agricoltore» (Gv
15,1).
La
santità di Artemide Zatti provoca in questo modo la paura
vocazionale del nostro tempo, paura che stringe il cuore nella
sfiducia davanti al mistero di Dio. Il
vangelo della vocazione
annunciato dalla vita di questo santo salesiano coadiutore mostra che
solo corrispondendo al sogno di Dio è possibile, ad ogni età
e in ogni situazione, sconfiggere la paralisi dell’io, con la
povertà del suo sguardo e delle sue misure, con l’angustia
della sua incertezza e del suo timore.
Quando
don Garrone – salesiano a propria volta di eminente virtù,
oltre che di grande competenza medica, acquisita attraverso il
servizio generoso ai malati – esorta Artemide malato di
tubercolosi a chiedere la grazia della guarigione per intercessione
della Vergine e con il voto di dedicarsi per tutta la vita ai malati,
la fede di Zatti dà buona prova di sé: semplice,
disinteressata, senza riserve, racchiusa in una parola: “Credetti!”.
“Credetti”,
ovvero quando basta una parola a dire la fede, perché la fede
è pura; e solo questa fede è vocazionalmente generosa,
per la levità della sua purezza che “mette ali al cuore
e non catene ai piedi”.
La
santità di Artemide Zatti raggiunge i nostri cammini
vocazionali, talvolta stanchi e grevi, con la forza dirompente di un
«credetti» che non è mai venuto meno: il presente
della fede che si fa continuo lungo la vita e la rende credibile. La
sua è stata una fede con una continua
unione con Dio.
Nelle testimonianze raccolte così si esprimeva Mons. M. Pérez:
«L’impressione che io ricevetti fu quella di un uomo
unito al Signore. L’orazione era come il respiro della sua
anima, tutto il suo comportamento dimostrava che viveva pienamente il
primo comandamento di Dio: lo amava con tutto il cuore, con tutta la
sua mente e con tutta la sua anima».
Siamo
chiamati a valorizzare la testimonianza di Zatti per rinnovare
l’ardore della nostra pastorale vocazionale e per offrire ai
giovani l’esempio di una vita che la solidità della fede
rende piena, semplice, coraggiosa, per la potenza dello Spirito e la
docilità del chiamato.
1.2
Il Vangelo della confidenza: «Promisi»
Il
Vangelo della vocazione,
del quale Zatti è testimone, anima un secondo verbo di
importanza fondamentale: promettere.
Delle
promesse umane oggi si sperimenta spesso la debolezza, si teme
l’inaffidabilità, si constata l’incapacità
ad essere definitive: di qui gli inverni vocazionali che stanno
colpendo la famiglia, le Congregazione in molte parti del mondo, la
Chiesa, e che rendono urgente l’annuncio del vangelo della
chiamata di Dio e della risposta del credente.
Von
Balthasar, riflettendo sull’essenza della vocazione, frutto di
un credere autentico, così scrive: «Non c’è
nessun camminare incontro all’amore senza almeno un accenno di
questo gesto
di consegna.
[…] [L’amore] vuole definitivamente rimettersi,
consegnarsi, affidarsi, racchiudersi. Vuole depositare presso l’amato
una volta per tutte la sua libertà di circolazione, per
lasciargli un pegno d’amore. Appena l’amore si desta
veramente alla vita, l’attimo temporale vuole essere
superato in una forma di eternità.
Amore a tempo, amore ad interruzione non è mai vero amore».
Artemide
Zatti, pur in giovane età e proprio in un grande momento di
prova, sente la chiamata alla pienezza dell’impegno di sé
in una promessa irrevocabile e radicale; quando in età matura,
testimoniando la sua gratitudine verso il Padre Evasio Garrone, suo
benefattore, rievocherà i primordi del proprio cammino di
consacrazione, Zatti potrà essere lapidario nel presentare il
cuore della sua adesione giovanile alla chiamata del Signore:
«credetti, promisi».
Il
“promisi”
di Zatti segue il suo “credetti”
ma anche ne plasma la radicalità e la qualità umana e
cristiana. Artemide crede perché promette e non solo promette
perché crede: in lui vediamo realizzata la regola della fede
che, se non può contare sulla disponibilità alla
promessa, alla consegna di sé, decade ad interesse spirituale,
a previdenza e contratto religioso.
Zatti
non attende garanzie per dedicare rischiosamente la sua vita, non
chiede di riscuotere il diritto al “centuplo quaggiù”
come condizione previa al suo gettare le reti; piuttosto «si
offerse con pronta disponibilità ad assistere un sacerdote
malato di tisi e ne contrasse il male: non disse una parola di
lamento, accolse la malattia come dono di Dio e ne portò con
fortezza e serenità le conseguenze».
Così
la generosità di Artemide, è pagata prima ancora della
professione religiosa, e il prezzo è alto: una malattia
debilitante, un sogno vocazionale infranto, una sofferenza acuta, e –
soprattutto – una totale incertezza. Ma al crocevia di fede e
promessa il vangelo della vocazione realizza in questa vita, sin
dalla giovinezza, prodigi di santità.
La
promessa di Zatti è pura, disinteressata, come la sua fede e
fa brillare l’integrità dell’abbandono al disegno
di Dio e la generosità del dono e dell’impegno di sé
che mostrano autentico spessore teologale: Artemide fa sua la vita
del Figlio obbediente che si lascia totalmente decidere e destinare
dall’amore del Padre per la salvezza del mondo.
L’alfabeto
vocazionale di Zatti è tanto profondo quanto semplice e
chiaro: «Credetti, promisi. Zatti crede e promette con
radicalità evangelica perché già ha praticato la
Passione del Signore quale regola della sua fede e della sua
dedizione, come non si stanca di ripetere nelle sue lettere ai
familiari: “Le nostre gioie sono le croci, il nostro conforto è
il patire, la nostra vita sono le lacrime, ma con a fianco la sempre
cara e inseparabile compagna, la speranza di raggiungere al bel
paradiso, quando sarà compiuto il nostro pellegrinaggio in
terra”».
La
croce è la regola della fede, e insegna come il credere
cristiano non sia un semplice conoscere qualcosa, ma affidarsi a
Qualcuno promettendoGli non qualcosa, ma se stessi. Formato dalla
croce Artemide prima ancora di intraprendere il cammino della vita
religiosa, non promette
ma
si
promette,
non fa
voto,
si
vota,
e così riflette i lineamenti del Figlio che «entrando
nel mondo, […] dice: Tu non hai voluto né sacrificio né
offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né
olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: “Ecco,
io vengo -poiché di me sta scritto nel rotolo del libro- per
fare, o Dio, la tua volontà”» (Eb
10, 5-7).
E,
sempre alla scuola del Signore Gesù, Zatti impara che alla
radicalità della promessa di sé corrisponde l’audacia
crescente della fede. Chi si dà completamente a Dio può
abbandonarsi alla certezza di ricevere tutto da Lui, e Artemide non
si stanca di ricordarlo nelle sue lettere: «Mi raccomando che
non abbiate paura o vergogna di domandare grazie. Domandate pure ed
otterrete; e più domandate, più otterrete; poiché
chi domanda molto riceve molto, chi poco, riceve poco, e chi niente
domanda, nulla riceve. […] Io non starò lì a
enumerare le grazie che dovete chiedere; ben voi lo sapete. Solo vi
metto sotto gli occhi una: ed è quella, che noi tutti possiamo
amare e servire Dio in questo mondo e poi goderlo nell’altro».
1.3
Il Vangelo della dedizione: «Guarii»
«Guarii»
è il verbo con il quale Zatti sigilla l’evento che lo
introduce nella vita salesiana.
Cosa
significa «Guarii»?
Certamente la tubercolosi che ne aveva minato la salute fu superata
da Zatti e in un modo che sorprese i medici: «Nel processo di
Viedma il Tribunale si domanda se la guarigione fu miracolosa. A
quanto ci è dato sapere, mancò per qualificarla tale la
istantaneità, ma, a detta dei dottori […] che conobbero
bene Zatti fino alla sua morte, fu straordinaria per la scarsezza e
la poca efficacia delle cure di allora, per la continuità
della guarigione e per la più che normale robustezza fisica di
cui godette poi sempre il Servo di Dio, nonostante la sua vita di
strapazzo. L’intervento della Madonna sembra innegabile, sia
che si trattasse di miracolo sia che fosse grazia straordinaria».
Il
dito di Dio però agì secondo il suo stile
inconfondibile: non estirpò il male riportando la vita di
Artemide alle condizioni previe alla malattia, e neppure dipanò
il mistero tipico di ogni disegno divino e di ogni esistenza umana.
Così, come sappiamo, «i Superiori, pur constatando i
miglioramenti della salute del Servo di Dio, non dovettero essere
pienamente persuasi sulle sue future possibilità. La
tubercolosi, a quei tempi, non dava mai sicurezza di guarigione e di
guarigione definitiva; il curriculum
di studi che il Servo di Dio avrebbe dovuto affrontare, alla sua età
(23-24 anni), era ancora lungo e non certo adatto ad un
tubercolotico; egli, d’altra parte, aveva già
incominciato a lavorare, e tutto fa credere con successo e con
reciproca soddisfazione, nella Farmacia in una occupazione adatta ad
un laico; forse Padre Garrone faceva qualche pressione per tenerlo
con sé nel suo lavoro. I Superiori allora, date tutte queste
circostanze, dovettero proporre al Servo di Dio – che
certamente, da tutto quello che appare nei suoi scritti, aveva deciso
di lasciare il mondo e di consacrarsi a Dio – di farsi
religioso salesiano, ma come coadiutore (confratello laico): la
soluzione sembrava la più prudente in vista della sua ancora
incerta salute: un lavoro materiale richiedeva meno sforzi di quanti
non se ne esigessero per un lungo periodo di studi severi».
Il
mistero di Dio si infittisce con la guarigione, e alla fede di
Artemide viene chiesta una purificazione forse più severa di
quella imposta dalla perdita della salute: il sacrificio
dell’orientamento vocazionale. Così Artemide è
condotto ad approfondire il cammino di svuotamento che Dio gli
richiede: la liberazione dalla malattia non è una riconquista
di forze, che permette a un giovane intraprendente di “riprendere
in mano la vita”. La guarigione, a suo modo, è il
deserto di una nuova povertà, perché la vita di Zatti
sia spazio libero per Dio, nella radicalità di un nuovo
abbandono.
Dio
guarisce Artemide dalla tubercolosi per rinnovare in lui il prodigio
della salvezza dall’attaccamento a se stesso, del distacco
anche dai propri progetti di bene: «C’è da
ritenere che abbandonare l’aspirazione al sacerdozio sia stata
per il Servo di Dio una grande sofferenza spirituale, tanto era lo
slancio e lo spirito di sacrificio con cui aveva intrapreso il
cammino verso questa meta. È però meraviglioso, e
indice di straordinaria forza spirituale, il fatto che non appaia mai
una parola di lamento od anche solo di rammarico e nostalgia […]
per questo capovolgimento nella prospettiva della sua vita».
«Guarii»:
è allora la voce della coerenza dell’alfabeto
vocazionale di Zatti. Quando Dio chiama e la sua creatura risponde,
lo Spirito non si limita a riparare la precarietà umana ma
compie il sogno di Dio «Ecco, io faccio nuove tutte le cose»
(Ap
21,5). Così, se la malattia inclina il cuore umano a
ripiegarsi su di sé, il credere e il promettere di Zatti,
nutriti dall’amore al Signore Gesù e alla Croce,
producono vera salute: una più grande dimenticanza di sé
e condiscendenza incondizionata a Dio, che lo porta ad essere l’umile
apostolo dei più poveri, dei malati e, tra questi, a diventare
l’apostolo dei casi più difficili; in breve, degli
abbandonati e degli scartati di questo mondo.
Artemide
rinato a più grande povertà è più arreso,
in confidenza piena e operosa, al disegno del Padre: «Ex
auditu
posso dire che [nella vita del Servo di Dio] c’è stata
una volontà generale che Dio fosse glorificato. In quel che lo
conobbi posso assicurare che vivesse per la gloria di Dio».
La
subordinazione di tutto alla gloria di Dio e il sacrificio delle
proprie vedute – compresi i progetti di bene – per
assecondare la sapienza di Dio che sola realizza la pienezza
dell’Amore, saranno essenziali non solo all’esperienza
spirituale di questo salesiano straordinario, ma pure alla pedagogia
del dolore
che dovrà praticare per la specificità della sua
missione.
Nel
“guarii” di Zatti si compie non solo una grazia ma una
scuola, ed entrambe plasmate dal dito di Dio per il bene dei
fratelli: libero dalla malattia Artemide servirà per una vita
i malati, dopo essere passato attraverso il vero
guarire
che lo renderà vero
medico
delle creature sulle quali si chinerà.
«Faceva
spesso il segno della Santa Croce e lo faceva fare agli infermi,
amava insegnarlo ai bambini. In lui la fede e i medicamenti formavano
una simbiosi, senza la fede non curava e nemmeno senza medicine.
Ugualmente non vedeva una dicotomia tra l’anima e il corpo; era
una sola cosa l’uomo, e curava questo uomo: corpo e anima».
Solo
perché condotto dalla mano di Dio a vivere il guarire come
morire a se stesso Zatti potrà farsi prossimo ai malati con il
farmaco dell’Amore Incarnato e Crocifisso, dispensando
conforto, luce e speranza.
2.
UN TESTIMONE DELLA PASQUA
Se
nella vita di Zatti – per il modo in cui fu raggiunto dalla
chiamata di Dio – brilla in forma originale e attualissima il
Vangelo della vocazione,
la sua semina apostolica si compie come arte della cura nella luce
della Pasqua.
La
coerenza pasquale è la regola di fedeltà di ogni
apostolato cristiano: nei santi la pratica di questa regola raggiunge
il fulgore, portando la vita di Dio dentro le fatiche degli uomini,
della storia, del mondo, edificando così la Chiesa.
Zatti
ha praticato con passione pasquale la fatica della sofferenza umana
ed ha così edificato la Chiesa come vero ospedale da campo
(come oggi continua a ripetere Papa Francesco), proprio trasformando
due ospedali sorti “alla fine del mondo” in cellule vive
della Chiesa.
Gli
ospedali di San José prima e poi di Sant’Isidro furono
tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento una
risorsa sanitaria preziosa e unica per la cura soprattutto dei poveri
di Viedma e della regione del Rio Negro: l’eroismo di Zatti ne
fece luoghi di irradiazione dell’amore di Dio dove la cura
della salute diventa esperienza di salvezza.
Zatti
ha consegnato la sua vita alla parabola del buon Samaritano. Il
Samaritano è Cristo, il Dio vicino (nel suo Figlio Amato) che
non conosce indifferenza e disprezzo, ma offre se stesso, in
anticipo, per guarire fin l’ultimo dei suoi figli e figlie, per
mezzo della prossimità dell’amore, così che il
male della storia non condanni nessuno di questi piccoli a perire
fuori da Gerusalemme.
Ecco
il miracolo di Dio: in quel fazzoletto di terra patagonica, dove
scorre la vita di Zatti, ha preso vita una pagina del Vangelo. Il
Buon Samaritano ha trovato volto, mani e passione, anzitutto per i
piccoli, i poveri, i peccatori, gli ultimi. Così un ospedale è
diventato la Locanda del Padre, è diventato segno di una
Chiesa che voleva essere ricca di doni di umanità e di Grazia,
dimora del comandamento dell’Amore di Dio e del Fratello, luogo
di salute quale pegno di Salvezza.
Sono
numerosi i testimoni che permettono di contemplare l’esperienza
di Chiesa accessibile in quell’ospedale da campo reso vivo dal
cuore infiammato di Zatti: dando loro la parola emerge di nuovo il
fascino di Artemide preoccupato di curare quanti a lui si affidavano,
sia con i rimedi dell’arte medica, sia con la presenza, la
simpatia, la preghiera per tutti e con tutti, e con l’espressione
di fede di tutti giorni di questo umile salesiano. Tutto questo si
rivelò certamente più efficace di tante medicine.
2.1.
Cura pasquale e servizio (diakonia)
della vita ferita
Dove
c’è santità la Chiesa si diffonde, e dove si
edifica la Chiesa c’è santità. Chi ha incontrato
Zatti, chi è stato accolto nel suo ospedale, ha fatto
esperienza di fraternità e in questa fraternità
esperienza di Chiesa.
Zatti
ha vissuto con radicalità evangelica la certezza che il
servizio, che è stata la sua caratteristica vocazionale – a
diakonia
– rende credibile, riconoscibile, amabile, il volto della Chiesa. La
porta del servizio attrae il cuore umano, specie quando è
provato dalla vita e dalla sofferenza, e apre all’esperienza
dell’incontro con Gesù, il vero Buon Samaritano, e Zatti
ha fatto del suo meglio per vivere come un buon samaritano.
«L’ospedale e le case dei poveri, visitati notte e giorno
viaggiando su una bicicletta, considerata ormai elemento storico
della città di Viedma, furono la frontiera della sua missione.
Visse la donazione totale di sé a Dio e la consacrazione di
tutte le sue forze al bene del prossimo».
Zatti
è testimone di servizio, e così come Gesù ha
donato se stesso sino alla fine, Zatti ha realizzato fino
all’eroismo, sui passi del suo Signore, una donazione e una
diakonia
pienamente cristiana. Meritano di essere sottolineati, con le parole
unanimi dei testimoni, i caratteri straordinari della diakonia
evangelica
di Zatti: l’universalità della sua dedicazione, la
totalità del dono di sé, la generosità nata con
Dio accanto, in obbedienza a Lui, compiuta in Lui e per Lui.
Che
il servizio di Zatti non conoscesse particolarismi e non facesse
preferenza di persone è sotto gli occhi di quanti lo hanno
conosciuto: «So che ha visitato la prigione per curare i
malati. Con gli increduli e i nemici della Chiesa era disponibile e
amabile. Ricordo la frase di un medico che commentando il titolo del
libro del Padre Entraigas “Il parente di tutti i poveri”
diceva che avrebbe dovuto essere corretto in “parente di tutti”
per l’equità con la quale [Zatti] non faceva distinzione
tra tutti quelli che lo cercavano».
Se
nel servizio e
nella
donazione di se stesso
da parte di Zatti c’era una preferenza per qualcuno, questa era
la preferenza insegnata dal Buon Pastore, sensibile soprattutto alla
sorte delle pecore più ferite e smarrite: «Fu una delle
predilezioni [di Zatti] la sua totale donazione a Dio in queste
persone umili, indifese o con infermità ripugnanti a tal punto
che quando qualcuno voleva mandarle a un ospizio perché erano
state molti anni nell’Ospedale San José rispondeva che
non si dovevano abbandonare questi veri parafulmini
dell’Ospedale».
Zatti
poi serviva con tutto se stesso, consumandosi in una generosità
senza calcolo nelle forme più disparate di un’attività
febbrile, orientata soltanto a corrispondere alle richieste di tutti:
«Siccome era a tutti nota la sua bontà e la sua buona
volontà nel servire gli altri, tutti si rivolgevano a lui per
le cose più disparate. […] I direttori delle Case
dell’Ispettoria scrivevano per consigli medici, gli mandavano
confratelli da assistere, affidavano al suo ospedale-cronicario
persone di servizio diventate inabili. Le Figlie di Maria
Ausiliatrice non erano da meno dei Salesiani nel chiedere favori. Gli
emigranti italiani chiedevano aiuti, facevano scrivere in Italia,
sollecitavano pratiche, coloro che erano stati ben curati
all’Ospedale, quasi fosse espressione di gratitudine, gli
inviavano parenti e amici da assistere per la stima che avevano delle
sue cure. Le autorità civili avevano spesso persone inabili da
sistemare e ricorrevano a Zatti. I carcerati e altre persone,
vedendolo in buoni rapporti con le autorità, si raccomandavano
perché chiedesse clemenza per loro o facesse procedere la
soluzione dei loro problemi».
Il
servizio di Zatti era poi continuativo e dimentico di sé e,
proprio per questo, non frenato da suscettibilità,
ingratitudini, corrispondenze mancate o richieste assillanti: «Nel
servo di Dio la preoccupazione per il prossimo era straordinaria nel
lavoro quotidiano; dalla mattina alla sera viveva per i suoi amati
infermi. Queste circostanze si moltiplicavano la notte, quando, a
qualunque ora lo chiamassero, egli accorreva rapidamente. […]
Mi consta che spesso abbia dovuto soffrire di pretese eccessive di
alcuni infermi, esigenze smodate, capricci, come il caso […]
di pazienti con infermità mentali. Il Servo di Dio non perdeva
mai la pazienza. Ricordo di averlo visto in più di una
occasione salire con cattivo tempo, freddo e pioggia con il suo
veicolo, una bicicletta non ultimo modello, per curare infermi tra la
popolazione andando per strade molto poco transitabili».
A
segnare poi profondamente la diakonia,
il
servizio a tutti,
di Zatti era il suo svolgersi in compagnia del Signore. A nessuno
sfuggiva la competenza di questo generoso infermiere, ma altrettanto
evidente era il suo essere in missione con Gesù: «Un
fatto personale molto concreto: essendo io novizio e poi sacerdote
novello, venni a Viedma per alcune pustole che mi uscivano
soprattutto sul collo e sulla faccia e il Servo di Dio sempre mi
accoglieva sorridente, mi curava cauterizzandomi con una punta
rovente canticchiando il Magnificat
mentre operava e incoraggiandomi poi a offrire quelle sofferenze per
la santa perseveranza nella vocazione».
Ancora,
in Zatti rifulgeva l’obbedienza a Dio e al suo disegno come
anima di un servizio umile e fiducioso, che doveva ispirare nei
poveri e nei malati sentimenti di abbandono in Dio. Tutto trovava in
Dio ispirazione, e tutto Zatti svolgeva secondo il comando di Dio,
così che il servizio di questo grande salesiano era una
pratica continua e affascinante del precetto dell’amore: egli
«amò Dio sopra ogni cosa. Per lui tutte le cose di
questa terra erano transitorie e secondarie. Per me Zatti era
costante, senza cedimenti nel suo amore a Dio e nella sua pietà.
Non solo negli atti di pietà ma in ogni servizio al prossimo
teneva sempre il nome di Dio sulla bocca. Esortò tutti coloro
che gli furono vicini a vivere la pietà. Zatti era
permanentemente un esempio, la sua pietà era superiore
all’ordinario».
Quella
di Zatti però, come accade sempre nei santi, è una
diakonia,
un
servizio
compiuto certo in obbedienza a Dio, ma soprattutto in nome di Dio,
prestando a Dio il volto, il cuore, le mani, nella certezza –
fonte di grande audacia – di essere piccolo strumento della sua
grande Potenza e Provvidenza. Così Zatti opera con generosità
straordinaria, ma con abbandono totale perché sa che ad agire,
in lui, è il suo Signore: «Sperò e confidò
sempre in Dio. La serenità con la quale superava le difficoltà
era una dimostrazione della sua speranza in Dio. Sempre diceva: “Dio
provvederà”, però lo diceva con piena confidenza
e speranza».
Zatti,
credente e uomo vero, è «mosso dalla carità verso
il prossimo perché in ogni malato vedeva Cristo sofferente.
Tanta era la bontà che usava con gli infermi che non negava
loro nulla»;
«per il Servo di Dio l’amore si manifestava nella carità
con la quale assisteva gli “altri Cristi”. Nella sua
concezione evangelica che tutto quello che faranno i suoi discepoli
al loro prossimo lo staranno facendo allo stesso Cristo, il Servo di
Dio si comportò abitualmente con tutti con carità,
anche quando si trattava di increduli o indifferenti».
O
vivendo in uscita una Chiesa del servizio, capace di raggiungere in
bicicletta i suoi poveri, o servendo quanti bussavano al suo ospedale
– di San José prima e di sant’Isidro poi –
perché vi incontrassero l’amore di Dio Zatti ha dato
tutto se stesso a Dio, divenendo servo del Signore, missionario
autentico della Chiesa nel nome del Signore Gesù.
2.2
Fraternità pasquale e comunione (koinonia)
nella vita condivisa
La
santità di Zatti ci porta nel cuore della Chiesa non solo per
la singolarità della sua diakonia,
ma anche per la qualità della comunione fiorita per il suo
donarsi agli altri. Cosa fosse per Zatti la comunione è
attestato tanto dalle testimonianze di chi ne ha visto l’azione,
quanto dal modo in cui attraversò i momenti più
faticosi che ne segnarono la vita.
Un
fatto per lui particolarmente doloroso si verificò quando i
superiori si orientarono per la demolizione dell’Ospedale di
San José, al quale Artemide aveva consacrato ogni energia; a
Viedma mancavano gli ambienti per l’episcopio e per edificare
una confacente dimora vescovile fu deciso l’abbattimento del
vecchio ospedale, con l’onere del trasferimento di tutti i
servizi sanitari negli spazi della Scuola agricola di Sant’Isidro,
sede di un’altra opera salesiana a Viedma.
Per
Zatti la demolizione non era una semplice operazione edile, era una
prova cruda e crocifiggente: davanti agli occhi non aveva solo le
macerie di un vecchio ospedale, ma il dubbio che con quelle mura
fosse crollata la sua vita e lì fossero finite anche le sue
rinunce e privazioni, incomprensioni e veglie, grattacapi e sudori,
dedizione agli altri e sacrificio di sé. A Zatti il calice non
fu risparmiato, ma rimase in piedi, con fortezza e dolcezza
cristiana: «All’epoca della demolizione dell’ospedale
san José aveva prima proposto che il palazzo vescovile fosse
costruito in altro luogo e il terreno fosse permutato; poi, data
l’inesorabilità della demolizione, che […]
sentiva enormemente data la sua estrema sensibilità umana, non
si ribellò né protestò; anzi, calmava coloro che
cercavano di farlo ribellare».
Come
sempre accade nella vita dei santi, la prova è insieme
crogiolo oscuro e dimostrazione luminosa: Zatti con la sua serenità
d’animo e con l’alacrità posta nell’allestire
la nuova sede dei servizi sanitari, dimostrò quale fosse il
fondamento della sua dedizione: il vero ospedale da lui edificato non
poteva essere ridotto in macerie perché era un’invenzione
della carità, di quella carità che «non avrà
mai fine» (1Cor 13,8), e che esprime il miracolo della
comunione, riflesso dell’eterna Vita di Dio. Il vero ospedale
di Zatti non era un edificio terreno, dedicato a San José o a
Sant’Isidro; in quegli ambienti la sua professionalità
accoglieva tutti, attraverso la porta del servizio, perché
facessero però esperienza vera e piena della tenerezza di Dio.
Zatti
non ha predicato il catechismo della comunione, ma con la sua santità
lo ha incarnato; e il suo ospedale non era un fabbricato imponente,
ma un miracolo evidente, quotidiano, di servizio e comunione. Qui «il
Servo di Dio dirigeva il personale, che era composto da persone varie
che abitavano nell’ospedale, come un superiore di una comunità
religiosa […] Il personale lo amava, lo venerò e ne
seguì alla lettera le regole. A ciascuno non è mai
mancato il necessario: morale, spirituale e tecnico per il disbrigo
dei suoi impegni e questo per la personale preoccupazione del Servo
di Dio».
Che
proprio la statura spirituale di Zatti ne facesse l’artefice
della comunione è persuasione di tutti: «Negli anni in
cui sono stato a scuola nel Collegio san Francesco di Sales,
l’Ospedale era una dipendenza del Collegio e si sapeva tutto
ciò che accadeva qui come là. Non ho mai sentito
parlare di liti o incomprensioni tra i collaboratori di Zatti che
potessero avere qualche rilievo ed essere causa di pettegolezzi in
paese o nella scuola».
La
comunione cristiana, quando si realizza, non passa inosservata per la
sua bellezza che sconvolge il mondo prostrato dal rancore e dalla
divisione; sono solo i santi però a conoscere fino in fondo il
prezzo della comunione, la sua estraneità allo spontaneismo,
all’immediatezza della simpatia, alla facilità senza
sacrificio. I santi sanno quanto costa la comunione perché
sanno qual è la sua fonte: il Costato squarciato del Signore,
che compie l’opera della riconciliazione tra gli uomini e con
gli uomini.
Zatti
sa che solo il Sangue del Signore crea comunione, e sceglie la via
della partecipazione fedele e quotidiana al sacrificio del Figlio,
con il sorriso sul volto, la fortezza nell’animo, la pace nel
cuore, le mani trafitte dal lavoro e dalla fatica. Rendendo quasi
impercettibile l’impegno richiesto dalla sua immolazione, Zatti
«era un uomo che irradiava pace, [uomo] di azione, dinamico,
non mostrava nervosismo, allegro. Era frequente una sua battuta […]
per rallegrare un malato […]. Era un uomo che non ha vacillato
nelle sue pratiche religiose, […] segno del suo sforzo per
migliorare sé stesso. Personalmente, ciò che ho notato
di più di lui sono state la sua carità e umiltà».
L’umiltà
di Zatti costruisce la Chiesa e rende cristiana la comunione della
quale egli stesso è artefice; chi non muore ogni giorno a se
stesso porta con sé la pesantezza dell’egoismo che
ferisce la comunione; solo l’umiltà guarisce le
relazioni e vince le lusinghe del potere, del controllo, della
seduzione, della prevaricazione. Zatti, senza moltiplicare parole o
discorsi, sa che solo con l’umiltà può essere
artefice di vera koinonia
frutto e condizione di una diakonia
efficace e discreta, che non crea dipendenza ma restituisce dignità;
solo l’umiltà serve in modo generativo, promuovendo una
comunione che cura il legame e promuove l’autonomia. L’umiltà
è la virtù di Dio perché è il segreto di
ogni padre, la speranza di ogni figlio, lo spirito di ogni vita vera.
Zatti
può essere servo e artefice di comunione per l’umiltà
che lo rende semplice figlio di Dio, vivo della Vita dello Spirito e
padre di tutti: «Penso che nel rapporto di Zatti con i
collaboratori non ci siano mai stati problemi perché era come
il padre di tutti. Ricordo che a tutti mancava molto quando era
assente per essere andato a Roma alla Canonizzazione di don Bosco»;
«il rapporto di don Zatti con l’ospedale era come quello
di un padre. Non conosco malintesi o difficoltà: se ci sono
state, credo non siano state da parte sua. Dalle infermiere con le
quali ho trattato […], non ho sentito altro che lodi e nessuna
lamentela».
2.3
Prossimità pasquale e martyria
della vita senza fine
Il
nostro confratello Artemide Zatti ha realmente testimoniato con la
sua vita (martyria)
che il Signore è risorto. «Io sono la luce del mondo»
(Gv
8,12) dice di sé il Signore. Il Vangelo è Luce che
vuole penetrare la vita degli uomini, e Luce per il mondo è la
Chiesa, sacramento vivente di Dio. Anche la santità di Zatti,
alimentata dalla Pasqua di Gesù, è luce, e ne fanno
esperienza soprattutto i poveri e i malati di Viedma. Zatti li
accoglie attraverso la porta del servizio, li custodisce tra le mura
della comunione ma per offrire loro, con la sua testimonianza di
vita, la luce del Vangelo, lo splendore della Pasqua che illumina la
Chiesa.
Credenti
e non credenti sono folgorati dalle parole e dai gesti di Zatti; la
sua testimonianza è senza ombre, straordinariamente salesiana,
raggiunge tutti e annuncia, attraverso due nomi, due lineamenti
decisivi del Dio di Gesù: Provvidenza e Paradiso.
Non
c’è Chiesa dove non c’è annuncio esplicito
del nome di Dio, annuncio pagato con il martirio della vita, nel
segno del sangue o della carità; dove si spingono il servizio
e la comunione di Zatti risuona l’annuncio del nome di Dio, di
questi due nomi, tanto cristiani e tanto salesiani: Provvidenza e
Paradiso.
Zatti
annuncia con la sua vita che tutto in Dio è amore, ma amore
concreto, attento, sconfinato e minuto, per ciascuna creatura:
l’amore di Dio è Provvidenza. La Provvidenza di Dio però
non è a tempo, bensì eterna, ed ecco il secondo nome:
Paradiso; Paradiso è il nome proprio del desiderio di Dio che
nella storia provvede alle sue creature per averle con sé per
sempre, per l’eternità.
Zatti
è maestro di questo alfabeto cristiano: «Era
suo costante desiderio che il Signore fosse conosciuto e amato. Lo
attestava la gioia che esprimeva quando un nuovo paziente, che non
sapeva nulla di Dio diventava devoto cristiano. La sua prima
sollecitudine era curare premurosamente e ispirare fiducia nella
divina Provvidenza».
Il
senso della Provvidenza non era la risposta obbligata a condizioni di
precarietà, una sorta di ultima spiaggia offerta ai naufraghi
per non affondare nei momenti difficili. Testimoniare la Provvidenza
per Zatti significava insegnare a parlare con Dio, a chiamarlo per
nome, con fiducia cristiana, perché «era molto convinto
dei principi evangelici e uno che era ben scolpito nel suo cuore e
nella sua mente era “cercare prima il Regno di Dio e la sua
giustizia e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta” (Mt
6,33). Aveva imparato alla scuola di Don Bosco – avendo letto
molto la sua vita – a non diffidare mai dell’aiuto di
Dio, soprattutto quando è onorato come vuole, in ogni nostro
prossimo».
Ma
una Provvidenza senza Paradiso non consentirebbe all’annuncio
del nome di Dio di reggere l’urto della storia, con il suo
carico di fatica, sofferenza, morte. Zatti animava, dentro e fuori
l’ospedale, una Chiesa sempre visitata dal dolore e dalla
morte, e questo chiedeva pienezza di fede e di testimonianza,
chiedeva di annunciare il nome dell’unico desiderio di Dio per
l’uomo: Paradiso. Quando testimoniava il Paradiso Zatti
mostrava la certezza «della vita eterna e della sua
acquisizione per grazia e buone opere; questo manifestava soprattutto
di fronte alla morte […]. L’ho ascoltato personalmente
gioire per aver potuto prestare aiuto religioso ai malati ed
esclamare […] “Oggi ne abbiamo mandati due o tre in
cielo”».
Con
questi due nomi di Dio Zatti ha evangelizzato la vita e la morte, la
gioia e il dolore, la salute e la malattia da vero testimone
cristiano, da martire, nel martirio quotidiano della carità.
L’annuncio e la martyria
di Zatti non divulgano un vangelo di circostanza o di opportunità,
ma diffondono Sale, Luce, Lievito, prestano volto, cuore e mani a un
Vangelo che chiede la vita e tutta la pervade, scioglie gli enigmi e
vince l’angoscia con il calore della Verità: «Da
quando l’ho conosciuto, ha sempre dato più importanza
alle pratiche religiose che al suo lavoro, sebbene lo facesse con
perseveranza. Citava spesso le Scritture, soprattutto i vangeli, per
consolare i malati o incoraggiare la virtù […]. Era
molto difficile per lui non mettere un pensiero spirituale nelle sue
conversazioni. Una volta, parlando con lui, accennavo alla scoperta
di alcune nuove medicine come la penicillina e i sulfamidici; il
Servo di Dio mi ha ascoltato e, quando ho finito di parlare, mi ha
detto: “È vero, è vero, ma la gente continuerà
comunque a morire”».
E
la verità del vangelo, tutta intera, illumina l’ospedale
di Zatti, come aveva illuminato l’Oratorio al tempo di don
Bosco: per questo nell’ospedale di Viedma come tra le mura di
Valdocco, non si teme la morte e non si moltiplicano gli espedienti
per addolcirne lo scandalo o nasconderne l’evidenza, inganni
pericolosi per il cuore umano. Zatti affrontava la morte con la
testimonianza del Vangelo della vita: una vita con i piedi per terra,
per questo operosa e concreta, ma con il cuore in cielo, e per questo
fiduciosa e serena: «L’unico motivo della sua vita è
stato proprio l’attesa di un premio celeste, non ha mai agito
per guadagnare denaro o reputazione, ha fatto tutto nella speranza
della felicità futura».
Il
suo impegno è stato, pur nella semplicità, quello di
vivere il Vangelo con il cuore radicato nel Premio finale è
portare il Dio della Provvidenza e del Paradiso dentro ogni piaga e
ogni morte umana, perché vi fioriscano Vita e Resurrezione.
Questo rendeva benedetta la testimonianza di Zatti e ne invocava la
presenza quando indispensabili erano le medicine preziose e rare
della speranza e della consolazione. Tutta la città di Viedma
lo sapeva, come hanno confermato con sorprendente unanimità i
testimoni: si chiamava sempre Zatti, e lui accorreva a rincuorare e
consolare, donando questa medicina cristiana che attingeva, per la
sua vita in Grazia di Dio, dallo Spirito stesso, il Consolatore. Così
diventava «straordinaria nel Servo di Dio la capacità di
infondere speranza negli infermi, fatto che contribuiva quasi
miracolosamente alla guarigione sollevando l’animo del
sofferente».
Zatti testimonia, fino al martirio della carità, che il
Signore è Dio del cielo e della terra. Zatti ne è
testimone, con la passione dei santi, che non conosce misura:
«Ricordo che un paziente disse a Zatti che lo preparava sempre
al cielo e che doveva prepararlo un po’ per la terra. Un altro
fatto mostra l’atmosfera dell’Ospedale: un’infermiera,
una volta, insistette per preparare alla morte un paziente che non
stava così male e che in effetti è ancora vivo».
2.4
Gioia pasquale e liturgia della vita redenta
Artemide
Zatti, con la sua fedeltà straordinaria agli appuntamenti
centrali della vita cristiana, si nutre del Pane della Parola, del
Pane del Perdono, del Pane del Cielo, e la sua vita si trasfigura,
sempre più profondamente, a beneficio di una missione ricca di
frutti crescenti. Così, la vita di Grazia, intensamente
vissuta da questo figlio di don Bosco, raggiunge quanti lo
incontrano, indistintamente: malati e collaboratori, confratelli e
autorità, poveri e benefattori, in Zatti toccano la vita del
Signore, per la forza del mistero sacramentale che si partecipa tra
le persone nella comunione del popolo di Dio. E così la Chiesa
tutta, nei sacramenti, per la potenza dello Spirito Santo, celebra il
mistero Pasquale e assicura agli uomini il nutrimento, per il cammino
e i rimedi che guariscono le ferite del male e della morte.
all’umanità
ferita dal male e dalla morte.
Questa
è la Chiesa: fiorisce e cresce dove il servizio e la comunione
annunciano il nome di Dio, testimoniano la Parola di Gesù,
sono nutriti dal suo Corpo, guariti dal suo Perdono. Zatti non
semplicemente fa tutto questo, ma è tutto questo; per la
corrispondenza alla Grazia, che rende santa la sua vita, in lui si
riconoscono non solo i gesti e le parole del Signore, ma si fa
esperienza della Sua stessa Vita: Zatti è un “tabernacolo
vivente”, e la sua testimonianza irradiante suscita domande,
propositi, conversione, anche in chi è lontano da una
partecipazione intima al mistero del Signore.
La
dedizione di Zatti, rivelando una radice più che umana,
diventa una prova, universalmente convincente, della forza
soprannaturale dei sacramenti; il suo, infatti, è «un
amore soprannaturale e straordinario per il prossimo. […] Era
disposto a qualsiasi sacrificio ed è per questo che in lui il
difficile sembrava facile. Penso che le circostanze ardue della sua
azione caritativa siano state: la carenza di personale, la richiesta
di assistenza in ogni momento, non farsi condizionare dalle
intemperie, servire ogni tipo di persone. Ricordo di un mio parente,
ammalato, cui venne a far visita in una giornata di pessimo tempo e
quando gli fu detto: “Con questo tempo esce, signor Zatti?”,
lui rispose: “Non ne ho un altro!”».
È
una regola della liturgia cristiana saper dare buona prova di sé
nella vita del credente con l’ordine, l’armonia, il
dinamismo efficace, e soprannaturale. Zatti è un cristiano, un
consacrato laico salesiano di don Bosco, è una pietra viva
della chiesa, è un testimone della Pasqua, perché nelle
sue opere diviene visibile il comandamento dell’Amore, che fa
riconoscere Dio nel prossimo e il prossimo in Dio; ma Zatti insegna,
con la sua vita, che la forza necessaria alla pratica di quel
comandamento è soprannaturale, e può venire solo da
Dio, dai suoi sacramenti e della preghiera e unione con Lui. «Zatti
esercitò la carità in circostanze difficili per la
carenza di risorse economiche. Anche perché la sua attività
eccedeva l’ordinario, per la quantità di ore che
dedicava ai suoi impegni senza omettere i suoi obblighi religiosi.
Per come lo conoscevamo ci chiedevamo come potesse sostenere uno
sforzo così grande senza il riposo che solitamente si
considera necessario».
Due
episodi meritano di essere ricordati, a esempio della liturgia della
vita per la quale Zatti è prima discepolo e poi apostolo del
Signore Crocifisso e Risorto; anzitutto la demolizione del vecchio
ospedale San José, con la necessità di trasferire i
malati a Sant’Isidro: «Non ho notizie che a Zatti sia
stata comunicata una data di sfratto, e di certo non aveva ricevuto
nulla dal suo Ispettore, altrimenti l’avrei saputo […].
Lo stato emotivo in cui è caduto Zatti quando è stato
necessario rimuovere i malati, perché le macerie non
crollassero su di loro, poteva essere psicologicamente fatale. Pianse
amaramente, ma dopo aver pregato davanti al Santissimo, si mise al
lavoro con serena energia»;
e poi il servizio ai morenti: «Stava per morire un giovanotto,
e Zatti conversava con lui dopo avergli fatto fare la comunione; a un
certo punto il ragazzo cominciò a gridare “Zatti, io
muoio!” e nello stesso momento si sollevava dal letto; Zatti,
guardandolo negli occhi, sorridendo gli disse: “Che bello, vai
in paradiso!” e il giovane si lasciò cadere con un
sorriso che ritraeva quello di Zatti, e che gli rimase impresso sul
volto».
Ecco
cosa accade quando l’Eucarestia diventa vita e il Mistero
pasquale pratica quotidiana: le grandezze umane si trasformano, per
la potenza dello Spirito, e ogni azione di un credente si compie in
Cristo, per Cristo e con Cristo, rendendo la vita una liturgia e
trasfondendo i doni santi della liturgia nella vita.
Il
nostro caro Artemide Zatti, debitore in tutto dei Misteri del
Signore, sa che tutto può solo grazie a Lui; di qui la sua
umiltà: «Ricordo che, essendo molto malato di febbre
tifoidea mio fratello Salvador, il Servo di Dio lo andava a curare
più volte al giorno. In una occasione, incontrandomi con lui
che si dirigeva alla casa di Salvador, afflitto gli dissi: “Signor
Zatti, per favore, salvi mio fratello!”. Egli voltandosi e
fissandomi negli occhi, con severità mi disse: “Non sia
blasfemo, solo Dio salva!”».
Quella
di Artemide Zatti è stata una vita fatta di donazione,
comunione, testimonianza del Signore risorto. Una vita piena di
grazie che l’ha portato ad una morte pienamente cristiana:
«Chiedendogli se i suoi dolori fossero continui, forti o no,
senza rispondere direttamente mi disse: “Sono un mezzo di
purificazione e sono contento perché mi rendo conto che sto
completando la Passione di Cristo, cosa che ho tanto inculcato negli
infermi”».
E
l’offerta di Zatti fu piena, discreta, serena e gioiosa, come
sigillo della sua liturgia. Merita di essere ripreso un fioretto, nel
quale, dietro il velo della simpatia, Zatti regala a chi lo assiste
il senso della sua vita, che Dio ha potuto spremere fino in fondo,
perché matura e piena. Pochi mesi prima della morte,
sorridendo della sua malattia – un tumore al fegato che
ingiallisce il volto – Zatti dice a un’infermiera che
sarà presto colorato, anche lui, con il trucco! Il suo sarà
però, come nei limoni, il colore della maturità, che
rende quel frutto pronto per essere spremuto, fino in fondo: «Voi
vi truccate? Anche io! Entro sei mesi vi darò la
dimostrazione. Il limone non serve se non è giallo».
3.
UN INVITO AD UN IMPEGNO STRAORDINARIO
Questo
era il titolo dell’ultima parte della lettera di don Vecchi, a
cui ho fatto riferimento più volte, e che vorrei conservare e
condividere ora. Nelle pagine precedenti ho cercato di delineare in
modo semplice ma incisivo la straordinaria figura del nostro
confratello salesiano coadiutore Artemide Zatti. Il suo percorso di
vita, impregnato e riempito di Dio, è un esempio per tutti.
Così come la sua santità. Davanti a questa grande
figura, nella nostra Congregazione si accende la coscienza più
viva della necessità e dell’importanza di uno speciale
impegno per promuovere oggi questa bella vocazione. Faccio mie le
parole di don Vecchi per chiedere ad ogni Ispettoria, ad ogni
comunità, e a ciascun confratello nei prossimi anni, fin da
ora, «un
impegno rinnovato, straordinario e specifico per la vocazione del
salesiano coadiutore, all’interno
della pastorale vocazionale, nel pregare per essa, nell’annunciarla
e proporla, nel chiamare, nell’accogliere e accompagnare, nel
viverla personalmente e insieme nella comunità».
Non mancano ricche pubblicazioni sulla figura del salesiano
coadiutore;
forse ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento è
rendere il nostro impegno più convincente. Ho ricordato spesso
nelle mie visite alle ispettorie e anche nelle mie lettere che
dobbiamo essere prima di tutto uomini di fede, oggi più che
mai abbandonati al Signore. Molte altre strategie e piani possono
aiutarci, ma ci faranno uscire da una difficoltà profonda solo
la fiducia
nel Signore e il ricorso a Lui.
La seguente testimonianza di un confratello coadiutore ha, a mio
avviso, una forza particolare: «Anche oggi risuona il “Vieni
e seguimi”. Ed
è sempre uno stupore constatare che anche oggi ci sono giovani
a cui nulla mancherebbe per orientarsi verso il sacerdozio e invece
fanno la scelta del laico consacrato anche nella Congregazione
Salesiana. Perciò nella pastorale vocazionale bisogna credere
in questa vocazione in sé completa e trasmetterne per osmosi
la stima, senza operare forzature e distorsioni in direzione della
figura clericale. Bisogna essere convinti che ci sono giovani che non
si identificano nel modello presbiterale, mentre si sentono attratti
dal modello del laico consacrato. Quali i motivi di questa scelta?
Tutte le motivazioni sono insufficienti: al fondo resta il mistero
della Grazia e della libertà».
A
questo punto vorrei invitarvi ad approfondire le prossime
pubblicazioni che usciranno sia su Sant’Artemide Zatti che
sulla vocazione del coadiutore salesiano nella nostra Congregazione,
nelle varie Regioni, e nelle proposte di entrambi i Settori della
Pastorale Giovanile e della Formazione.
Non
mancheranno gli stimoli, le riflessioni, e soprattutto i doni di
intercessione del nuovo santo in modo particolare per i suoi
confratelli salesiani coadiutori nel mondo, per quelli che già
ci sono e per quelli che verranno con la Grazia di Dio.
La
forza e la bellezza di un invito
Credo
che non si possa terminare il confronto con la vita di Artemide Zatti
senza evocare, ancora una volta, una lettera del 1986, del cardinale
Jorge Mario Bergoglio, oggi Papa Francesco, scritta a un salesiano, a
testimonianza di una grazia ricevuta per intercessione di Zatti.
La
vicenda è nota: quand’era Provinciale dei Gesuiti
dell’Argentina, padre Bergoglio affidò a Zatti la
richiesta al Signore di sante vocazioni alla vita consacrata laicale
per la Compagnia di Gesù e la sua Provincia ebbe la grazia, in
un decennio, di ventitré nuove vocazioni di religiosi
fratelli.
L’episodio
è rilevante non solo per i protagonisti della vicenda –
il Padrone della Messe, un Santo coadiutore salesiano, l’attuale
Successore di Pietro – ma per il suo contenuto: la forza
vocazionale della testimonianza di Zatti.
Stupisce
che il primo salesiano canonizzato non per il martirio del sangue sia
un coadiutore, e un coadiutore che rinuncia, in radicale obbedienza a
Dio, alla stessa forma della vocazione dalla quale era stato
affascinato, quella presbiterale, per stare con don Bosco, svolgendo
poi un servizio sacrificato nel mondo della malattia e della
sofferenza.
Non
può sfuggire però la forte bellezza di questa
testimonianza; in lui brillano gli amori fondamentali che devono
infiammare il cuore del Salesiano: l’amore per Dio e per la sua
volontà, l’amore per il prossimo, che nelle sue membra
sofferenti è il Volto vicino di Gesù Crocifisso,
l’amore alla Madre del Signore, Mediatrice di ogni grazia,
l’amore a don Bosco che ad ogni salesiano promette pane, lavoro
e Paradiso.
Questi
amori brillano nella luminosa grandezza della vita religiosa di
Artemide, abbracciata con gioiosa radicalità e intraprendenza
generosa.
Il
nostro confratello Artemide Zatti ci mostra quanto il mondo sia
sensibile alla testimonianza della vita religiosa, purché tale
testimonianza sia vera, credibile, autentica: il trionfo dei suoi
funerali, la fama di santità, la venerazione della sua tomba
sono segni chiari di quanto tutti abbiano riconosciuto il dito di Dio
in azione in questo salesiano generoso e fedele: «in
proporzione agli abitanti di Viedma fu impressionante la quantità
di gente che accorse ai funerali. Da ogni dove accorreva gente umile
con piccoli mazzi di fiori. Oltre alle autorità molte altre
persone. Nei giorni [successivi alla morte] le persone, erano
convinte che fosse morto un santo; alcuni si recavano alla tomba
sperando miracoli: pregavano, portavano fiori».
La
vita di Artemide Zatti ha svegliato una città, e oggi tocca
l’intero mondo, perché ha parlato di Dio: ha portato tra
i poveri e i malati, con una pratica esemplare della castità,
il profumo dell’amore verginale e fecondo di Dio; ha donato a
tutti la ricchezza della fede, pagandola con una povertà amata
fino a cedere la propria camera a un infermo o a portarvi un morto
per sottrarlo alla vista degli altri malati in un ultimo gesto di
tenerezza e pietà; ha insegnato la libertà vera,
obbedendo a prezzo di lacrime amare alla volontà dei superiori
riconoscendoli mediatori del disegno di Dio.
Religioso
esemplare, con questa testimonianza, insegna a tutti che la salute da
custodire sopra ogni bene è quella dell’anima, di quella
nostra anima tanto preziosa perché da Dio viene e a Lui
aspira, spesso inconsapevolmente, nel desiderio di trovare, tra le
sue braccia, Amore eterno.
Possano
gli amori di Zatti accendere i nostri amori; possano la sua
testimonianza dell’Assoluto di Dio, della grandezza dell’anima
e della nostra vera Patria ispirare i nostri gesti e la nostra
passione pastorale, per una nuova fedeltà apostolica e
rinnovata fecondità vocazionale. Che non ci manchi mai, come
ha sempre cercato Artemide Zatti, la protezione materna
dell’Ausiliatrice, e che la devozione alla Madre in ogni casa
salesiana del mondo, e in ogni angolo dove è presente la
Famiglia di Don Bosco, sia una strada sicura che ci aiuti a vivere
una santità come quella del nostro confratello.
Concludo
queste parole proponendo una preghiera al Padre per intercessione del
nuovo santo coadiutore salesiano, sant’Artemide Zatti.
Preghiera
di intercessione
per
chiedere vocazioni di salesiani laici
O
Dio, che in sant’Artemide Zatti
ci
hai dato un modello di salesiano coadiutore,
che
docile alla tua chiamata,
con
la compassione del Buon samaritano,
si
è fatto prossimo a ogni uomo,
aiutaci
a riconoscere il dono di questa vocazione,
che
testimonia al mondo la bellezza della vita consacrata.
Donaci
il coraggio di proporre ai giovani
questa
forma di vita evangelica
al
servizio dei piccoli e dei poveri,
e
fa’ che coloro che tu chiami per questa via,
rispondano
generosamente al tuo invito.
Te
lo chiediamo per l’intercessione di Sant’Artemide Zatti
e
per la mediazione di Cristo Signore.
Amen.
Con
vero affetto e uniti nel Signore con la mutua preghiera vi saluto
Ángel
Fernández Artime, sdb
Rettor
Maggiore