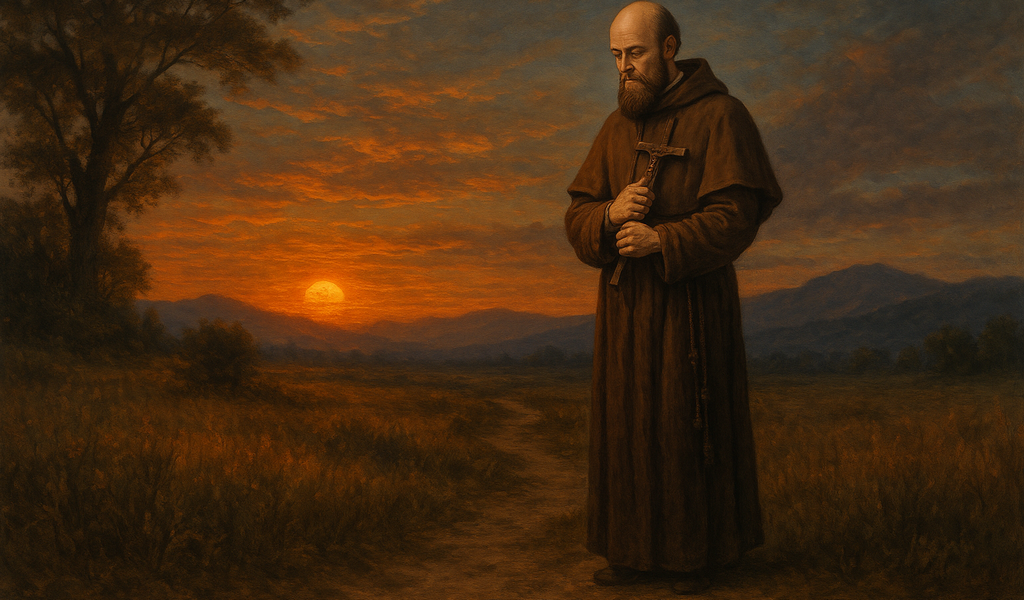Tempo per lettura: 11 min.
Con ogni probabilità è stato l’avvento della Riforma protestante a porre all’ordine del giorno il problema della coscienza, e, più precisamente, della «libertà di coscienza». In una lettera del 1597 a Clemente VIII, il prevosto di Sales deplorava la «tirannia» che lo «stato di Ginevra» faceva pesare «sulle coscienze dei cattolici». Domandava alla santa Sede di intervenire presso il re di Francia per ottenere che i Ginevrini concedessero «ciò che chiamano libertà di coscienza». Contrario a soluzioni militari della crisi protestante, faceva intravedere nella libertas conscientiae una possibile via d’uscita dal confronto violento, a condizione che la reciprocità fosse rispettata. Rivendicata da Ginevra a favore della Riforma, e da Francesco di Sales a beneficio del cattolicesimo, la libertà di coscienza stava per divenire uno dei pilastri della mentalità moderna.
Dignità della persona umana
La dignità dell’individuo risiede nella coscienza, e la coscienza è in primo luogo sinonimo di sincerità, onestà, franchezza, convinzione. Il prevosto di Sales riconosceva ad esempio, «per scaricare la sua coscienza», che il progetto delle Controversie gli era stato in qualche modo imposto da altri Quando presentava le sue ragioni a favore della dottrina e della pratica cattolica, si preoccupava di precisare che lo faceva «in coscienza». «Ditemi in coscienza», domandava ai suoi contradditori. La «buona coscienza», infatti, fa sì che uno eviti certi atti che lo mettono in contraddizione con sé stesso.
Tuttavia, la coscienza soggettiva individuale non può essere presa sempre come garante della verità oggettiva. Non si è sempre obbligati a credere ciò che uno vi dice in coscienza. «Mostratemi chiaramente – dice il prevosto ai signori di Thonon – che non mentite affatto, che proprio non mi ingannate, quando mi dite che in coscienza avete avuto questa o quell’ispirazione». La coscienza può essere vittima dell’illusione, in forma volontaria o anche involontariamente. «Gli avari incalliti, non soltanto non confessano di esserlo, ma non pensano in coscienza di esserlo».
La formazione della coscienza è un compito essenziale, perché la libertà di coscienza comporta il rischio di «far il bene e il male», ma «scegliere il male non è usare, bensì abusare della nostra libertà». È un compito duro, perché la coscienza talvolta ci appare come un avversario che «combatte sempre contro noi e per noi»: essa «oppone costante resistenza alle nostre cattive inclinazioni», ma lo fa «per la nostra salvezza». Quando uno pecca, «il rimorso interiore si muove contro la sua coscienza con la spada in pugno», ma lo fa per «trafiggerla con un santo timore».
Un mezzo per esercitare una libertà responsabile è la pratica dell’«esame di coscienza». Fare l’esame di coscienza è come seguire l’esempio delle colombe che si guardano «con occhi limpidi e puri», «si puliscono con cura e si ornano meglio che possono». Filotea è invitata a fare questo esame tutte le sere, prima di andare a coricarsi, chiedendosi «come ci si è comportati nelle varie ore della giornata; per farlo più facilmente si penserà a dove, con chi e a quali occupazioni ci si è dedicati».
Una volta all’anno dovremo fare un esame approfondito dello «stato della nostra anima» davanti a Dio, al prossimo e a noi stessi, senza dimenticare un «esame degli affetti della nostra anima». L’esame – dice Francesco di Sales alle visitandine – vi condurrà a sondare «a fondo la vostra coscienza».
Come alleggerire la coscienza quando uno la sente carica di un errore o di uno fallo? Certuni lo fanno in malo modo, giudicando e accusando gli altri «di vizi di cui sono succubi», pensando così di «addolcire i rimorsi della loro coscienza». In tal modo uno moltiplica il rischio di fare giudizi temerari. Al contrario, «coloro che si prendono correttamente cura della loro coscienza non sono affatto soggetti a giudizi temerari». Conviene considerare a parte il caso dei genitori, degli educatori e dei responsabili del bene pubblico, perché «una buona parte della loro coscienza consiste nel vegliare attentamente sulla coscienza degli altri».
Il rispetto di sé stessi
Dall’affermazione della dignità e della responsabilità di ognuno dovrà nascere il rispetto di sé. Già Socrate e tutta l’antichità pagana e cristiana ne avevano mostrato il cammino:
È un detto dei filosofi, che però è stato ritenuto valido dai dottori cristiani: «Conosci te stesso», ossia, conosci l’eccellenza della tua anima per non avvilirla e disprezzarla.
Certi nostri atti costituiscono non solo un’offesa di Dio, ma anche un’offesa della dignità della persona umana e della ragione. Le loro conseguenze sono deplorevoli:
La rassomiglianza e immagine di Dio, che portiamo in noi, viene imbrattata e sfigurata, la dignità del nostro spirito disonorata, e noi siamo resi simili agli animali senza ragione […], rendendoci schiavi delle nostre passioni e rovesciando l’ordine della ragione.
Ci sono estasi e rapimenti che ci innalzano al di sopra della nostra condizione naturale e altri che ci abbassano: «O uomini, fino a quando sarete così insensati – scrive l’autore del Teotimo – dal voler calpestare la vostra dignità naturale, discendendo volontariamente e precipitandovi nella condizione delle bestie?».
Il rispetto di sé stessi consentirà di evitare due pericoli opposti: l’orgoglio e il disprezzo dei doni che uno ha. In un secolo in cui il senso dell’onore era esaltato al massimo, Francesco di Sales ha dovuto intervenire per denunciare misfatti, in particolare nel problema del duello, che gli faceva «rizzare i capelli in testa», e più ancora l’orgoglio insensato che ne era la causa. «Sono scandalizzato» – scriveva alla sposa di un marito duellante – ; «in verità, non riesco a pensare come si possa avere un coraggio tanto sregolato persino per bagattelle e cose da nulla». Battendosi in duello è come se «diventassero l’uno carnefice dell’altro».
Altri, al contrario, non osano riconoscere i doni ricevuti e peccano così contro il dovere della riconoscenza. Francesco di Sales denuncia «certa falsa e sciocca umiltà che impedisce di scoprire il buono che c’è in loro». Hanno torto, perché «i beni che Dio ha posto in noi vanno riconosciuti, stimati e onorati sinceramente».
Il primo prossimo che devo rispettare e amare, sembra voler dire il vescovo di Ginevra, è il proprio io. Il vero amore verso me stesso e il rispetto dovutogli esigono che tenda alla perfezione e che mi corregga, se necessario, ma dolcemente, ragionevolmente e «seguendo la strada della compassione» piuttosto che quella dell’ira e del furore.
Esiste infatti un amore di sé stessi non soltanto legittimo, ma anche benefico e comandato: «La carità ben ordinata incomincia da sé stessi» – dice il proverbio – e rispecchia bene il pensiero di Francesco di Sales, ma a condizione di non confondere l’amore di sé con l’amor proprio. L’amore di sé è buono, e Filotea è invitata a interrogarsi sul modo con cui ama sé stessa:
Tenete un buon ordine nell’amore di voi stessa? Perché soltanto il disordinato amore di noi stessi può mandarci in rovina. Ora, l’amore ordinato vuole che amiamo l’anima più del corpo, che cerchiamo di procurarci le virtù più di ogni altra cosa.
Al contrario, l’amor proprio è un amore egoista, «narcisista», gonfio di sé stesso, geloso della propria bellezza e unicamente preoccupato del proprio interesse: «Narciso – dicono i profani – era un giovane cosi sdegnoso da non voler offrire il proprio amore a nessun altro; e infine, contemplandosi in una limpida fontana fu totalmente rapito dalla sua bellezza».
Il «rispetto dovuto alle persone»
Se si rispetta sé stessi si sarà più preparati e disposti a rispettare gli altri. Il fatto di essere «l’immagine e la somiglianza di Dio» ha come corollario l’asserto secondo cui «tutti gli esseri umani godono della stessa dignità». Francesco di Sales, pur vivendo in una società segnata dall’antico regime, fortemente disuguale, ha promosso un pensiero e una prassi caratterizzate dal «rispetto dovuto alle persone».
Bisogna iniziare dai bambini. La madre di san Bernardo – dice l’autore della Filotea – amava i suoi figli appena nati «con rispetto come una cosa sacra che Dio le aveva affidato». Un rimprovero molto grave rivolto dal vescovo di Ginevra ai pagani riguardava il loro disprezzo della vita di esseri indifesi. Il rispetto del bimbo che sta per nascere emerge in questo passo di una lettera, redatta secondo la retorica barocca dell’epoca, indirizzata da Francesco di Sales a una donna incinta. La incoraggia spiegandole che il bimbo che si sta formando nelle sue viscere non è soltanto «un’immagine vivente della divina Maestà», ma anche l’immagine di sua madre. Raccomanda a un’altra donna:
Offrite sovente alla gloria eterna del vostro Creatore la creaturina alla cui formazione vi ha voluto assumere come sua cooperatrice.
Un altro risvolto del rispetto dovuto agli altri riguarda il tema della libertà. La scoperta di nuove terre aveva avuto, come conseguenza nefasta, il riemergere della schiavitù, che richiamava le pratiche degli antichi romani al tempo del paganesimo. La vendita di esseri umani li degradava al rango delle bestie:
Un giorno, Marcantonio comprò da un mercante due giovanetti; allora, come avviene ancora oggi in qualche contrada, si vendevano i bambini; c’erano degli uomini che se li procuravano e poi li trafficavano come si fa per i cavalli nei nostri paesi.
Il rispetto degli altri è continuamente minacciato in forma più sottile dalla maldicenza e dalla calunnia. Francesco di Sales insiste parecchio sui «peccati di lingua». Un capitolo della Filotea che tratta esplicitamente di tale argomento è intitolato L’onestà nelle parole e rispetto che si deve alle persone. Rovinare la reputazione di qualcuno è commettere un «omicidio spirituale»; è sottrarre «la vita civile» a colui di cui si parla male. Così pure, «biasimando il vizio», ci si sforzerà di risparmiare il più possibile «la persona implicata in esso».
Certe categorie di persone sono facilmente denigrate o disprezzate. Francesco di Sales difende la dignità della gente del popolo fondandosi sul Vangelo: «San Pietro – commenta – era un uomo rude, grossolano, un vecchio pescatore, un mestierante di bassa condizione; san Giovanni, al contrario, era un gentiluomo, dolce, amabile, saggio; san Pietro, invece, ignorante». Orbene, è stato san Pietro ad essere scelto per guidare gli altri e per essere il «superiore universale».
Proclama la dignità dei malati, dicendo che «le anime che sono in croce sono dichiarate regine». Denunciando la «crudeltà verso i poveri» ed esaltando la «dignità dei poveri», giustifica e precisa l’atteggiamento che si deve tenere verso di loro, spiegando «come dobbiamo onorarli e quindi visitarli come rappresentanti di Nostro Signore». Nessuno è inutile, nessuno è insignificante: «Non vi è al mondo oggetto che non possa essere utile per qualche cosa; ma bisogna saperne trovare l’uso e il luogo».
L’«uno-diverso» salesiano
Il problema che da sempre ha tormentato le società umane è quello di conciliare tra loro la dignità e la libertà di ogni individuo con quelle degli altri. Ricevette da Francesco di Sales un chiarimento originale grazie all’invenzione di una nuova parola. Infatti, ammesso che l’universo è formato da «tutte le cose create, visibili e invisibili» e che «la loro diversità viene ricondotta a unità», il vescovo Ginevra propose di chiamarlo «uno-diverso», ossia «unico e diverso, unico con diversità e diverso con unità».
Per lui, ogni essere è unico. Le persone sono come le perle di cui parla Plinio: «sono talmente uniche, ciascuna nella sua qualità, che non se ne trovano mai due perfettamente uguali». È significativo che le sue due opere principali, l’Introduzione alla vita devota e il Trattato dell’amore di Dio siano indirizzate a una persona singola, Filotea e Teotimo. Quale varietà e diversità tra gli esseri! «Senza dubbio, come vediamo che non si trovano mai due uomini perfettamente uguali quanto ai doni della natura, così non se ne trovano mai di perfettamente uguali quanto ai doni soprannaturali». La varietà lo incantava anche da un punto di vista puramente estetico, ma temeva una curiosità indiscreta sulle sue cause:
Se qualcuno si ponesse la domanda perché Dio abbia fatto i cocomeri più grossi delle fragole, o i gigli più grandi delle violette; perché il rosmarino non sia una rosa o perché il garofano non sia una calendola; perché il pavone sia più bello di un pipistrello, o perché il fico sia dolce e il limone aspro, si riderebbe delle sue domande e gli si direbbe: pover’uomo, siccome la bellezza del mondo richiede varietà, è necessario che nelle cose ci siano perfezioni diverse e differenziate e che l’una non sia l’altra; ecco perché le une sono piccole, le altre grandi, le une aspre, le altre dolci, le une più belle, le altre meno. […] Tutte hanno il loro pregio, la loro grazia, il loro splendore, e tutte, viste nell’insieme delle loro varietà, costituiscono un meraviglioso spettacolo di bellezza.
La diversità non ostacola l’unità, tutt’altro la rende ancor più ricca e bella. Ogni fiore ha le sue caratteristiche, che lo distinguono da tutti gli altri: «Non è proprio delle rose essere bianche, mi sembra, perché quelle vermiglie sono più belle e hanno un profumo migliore, il quale però è proprio del giglio». Certo, Francesco di Sales non sopporta la confusione e il disordine, ma è ugualmente nemico dell’uniformità. La diversità degli esseri può condurre alla dispersione e alla rottura della comunione, ma se c’è l’amore, «vincolo della perfezione», niente è perduto, al contrario, la diversità è esaltata dall’unione.
In Francesco di Sales c’è sicuramente una reale cultura dell’individuo, ma questa non è mai una chiusura al gruppo, alla comunità o alla società. Egli vede spontaneamente l’individuo inserito in un contesto o «stato» di vita, che segna marcatamente l’identità e l’appartenenza di ciascuno. Non sarà possibile fissare un programma o un progetto uguale per tutti, per il semplice fatto che sarà applicato e attuato in maniera diversa «per il gentiluomo, per l’artigiano, per il valletto, per il principe, per la vedova, per la giovane, per la sposata»; bisogna inoltre adattarlo «alle forze e ai doveri di ognuno in particolare. Il vescovo di Ginevra vede la società ripartita in spazi vitali caratterizzati dall’appartenenza sociale e solidarietà di gruppo, come quando tratta «della compagnia di soldati, della bottega degli artigiani, della corte dei principi, della famiglia di gente sposata».
L’amore personalizza e, quindi, individualizza. L’affetto che lega una persona a un’altra è unico, come dimostra Francesco di Sales nel suo rapporto con la signora di Chantal: «Ogni affetto ha una sua peculiarità che lo differenzia dagli altri; quello che provo per voi possiede una certa particolarità che mi consola infinitamente, e, per dire tutto, per me è oltremodo fruttuoso». Il sole illumina tutti e ciascuno: «rischiarando un angolo della terra, non lo rischiara meno di quel che farebbe se non risplendesse altrove, ma solamente in quell’angolo».
L’essere umano è in divenire
Umanista cristiano, Francesco di Sales crede infine alla possibilità che la persona umana ha di perfezionarsi. Erasmo aveva forgiato la formula: Homines non nascuntur sed finguntur. Mentre l’animale è un essere predeterminato, guidato dall’istinto, l’uomo, al contrario, è in perpetua evoluzione. Non solo cambia, ma può cambiare sé stesso, tanto in meglio che in peggio.
Ciò che preoccupava interamente l’autore del Teotimo era perfezionare sé stesso e aiutare gli altri a perfezionarsi, e non soltanto in ambito religioso, bensì in ogni cosa. Dalla nascita alla tomba, l’uomo è in una situazione di apprendista. Imitiamo il coccodrillo che «non cessa mai di crescere fin tanto che vive». Infatti, «rimanere in uno stesso stato a lungo non è possibile: chi non avanza, indietreggia in questo traffico; chi non sale, scende in questa scala; chi non vince è vinto in questo combattimento». Egli cita san Bernardo che diceva: «È scritto in modo particolare per l’uomo, che non si troverà mai nello stesso stato: bisogna che avanzi o indietreggi». Andiamo avanti:
Non sai che sei in cammino e che il camino non è fatto per sedersi, ma per andare avanti? Ed è talmente fatto per avanzare, che muoversi in avanti si chiama camminare.
Ciò significa anche che la persona umana è educabile, capace di apprendere, di correggersi e di migliorarsi. E ciò è vero a tutti i livelli. L’età a volte non c’entra per nulla. Guardate questi fanciulli cantori della cattedrale, che superano di gran lunga le capacità del loro vescovo in questo loro ambito: «Ammiro questi bambini – diceva – che a mala pena sanno parlare e che cantano già la loro parte; comprendono tutti i segni e le regole musicali, mentre io non saprei proprio come cavarmela, io che sono un uomo fatto e che si vorrebbe far passare per un grande personaggio». Nessuno in questo mondo è perfetto:
Ci sono persone di loro natura leggere, altre sgarbate, altre ancora ben restie ad ascoltare le opinioni altrui, e altre infine portate all’indignazione, altre alla collera e altre all’amore; per farla breve, troviamo ben poche persone in cui non sia possibile scoprire l’una o l’altra di simili imperfezioni.
Si deve allora disperare di poter migliorare il proprio temperamento, correggendo qualcuna delle nostre naturali inclinazioni? Niente affatto.
Per quanto, infatti, siano in ciascuno di noi come proprie e naturali, se con l’applicazione a un attaccamento contrario si possono correggere e regolare, e perfino uno può liberarsene e purificarsi, allora, vi dico Filotea, che bisogna farlo. Si è pur trovato il modo di far diventare dolci i mandorli amari: basta forarli al piede e farne uscire il succo; perché mai non potremmo allora far uscire le nostre inclinazioni perverse, per diventare così migliori?
Di qui la conclusione ottimista ma esigente: «Non c’è natura buona che non si possa far diventare malvagia, tramite abitudini viziose; non c’è natura tanto perversa che non si possa, anzitutto con la grazia di Dio e poi con l’impegno industrioso e la diligenza, domare e vincere». Se l’uomo è educabile, bisogna non disperare di nessuno e guardarsi bene dai pregiudizi nei confronti delle persone:
Non dite: quel tale è un ubriacone, anche se l’avete visto ubriaco; è un adultero, per averlo visto peccare; è un incestuoso, per averlo colto in quella disgrazia; perché un solo atto non basta per dare il nome alla cosa. […] E anche quando un uomo fosse stato a lungo vizioso, si correrebbe lo stesso il rischio di mentire chiamandolo vizioso.
La persona umana non ha mai terminato di coltivare il suo giardino. È la lezione che il fondatore delle visitandine inculcava loro, quando le chiamava «a coltivare la terra e il giardino» dei loro cuori e dei loro spiriti, perché non esiste «uomo tanto perfetto da non aver bisogno di impegnarsi sia per crescere nella perfezione e sia per conservarla».