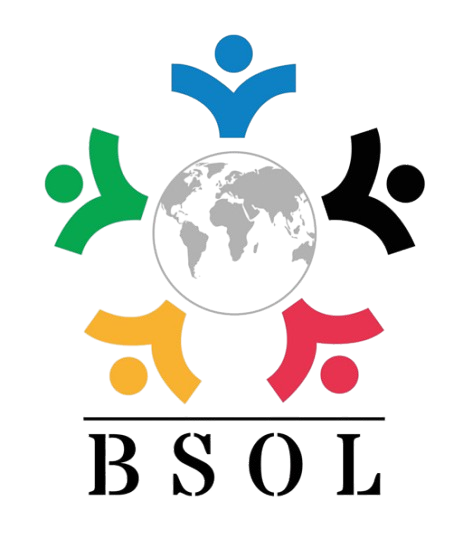Tempo per lettura: 10 min.
«Valoroso, obbediente, buon cittadino e magnanimo», tali erano secondo Francesco di Sales alcune delle qualità dell’uomo sollecito del bene pubblico. Il valore, spiegava, mi porta a «intraprendere per ragione le cose pericolose»; l’obbedienza è dovuta «al principe che servo»; la magnanimità consiste «nella grandezza di quell’azione» che si intraprende in vista del bene comune. Infine, per essere «buon cittadino», bisogna avere «l’amore verso il pubblico» e «l’affetto verso la propria patria». Anche se la parola cittadino sotto l’antico regime designava ancora solo l’abitante di una città, si vede che l’espressione «buon cittadino» era legata all’«amore verso il pubblico».
Amare e servire il proprio paese
Il buon cittadino ama il suo paese, il che significa che lo preferisce a ogni altro «in affetto», ma non necessariamente «in stima», perché nulla impedisce che si possa riconoscere il valore, persino la superiorità degli altri, un po’ come accade nel matrimonio:
Le donne devono preferire i loro mariti a chiunque altro, non in onore, ma in affetto; così ognuno preferisce il proprio paese in amore e non in stima, e ogni timoniere ama di più la nave su cui naviga rispetto alle altre, sebbene più ricche e meglio fornite.
L’attaccamento ai propri cari, alla propria famiglia, al proprio paese, ai propri amici, alle proprie «pecorelle», si trasformava in nostalgia quando era lontano. Fu così che nel 1618, all’inizio del suo ultimo soggiorno a Parigi, scrisse a una delle sue corrispondenti: «Sono qui fino a Pasqua; e credetemi, mia carissima figlia, poiché così dev’essere, ci sono di buon cuore, ma di un cuore che si compiacerebbe grandemente di essere tra le nostre piccolezze e nel mio paese».
L’amore per la patria si confondeva allora con l’obbedienza al principe e con il servizio che gli era dovuto. L’apprendistato della fedeltà al sovrano e del servizio allo Stato faceva parte dell’educazione. Avendo ottenuto che uno dei suoi nipoti fosse ammesso come paggio alla corte di Torino, riteneva che questo favore avrebbe permesso al ragazzo di «imparare nella sua infanzia i primi elementi di quel servizio al quale la sua nascita lo obbliga a dedicare tutta la sua vita».
Anche come vescovo, Francesco di Sales si comportava da suddito fedele, leale e devoto alla casa Savoia. Quando intravedeva dei pericoli, ne avvertiva il duca; gli consigliava un’alleanza quando la giudicava «estremamente utile agli affari» del suo signore. Quando seppe che il duca di Nemours complottava contro il duca di Savoia, si astenne prudentemente dal frequentarlo, citando il «vecchio insegnamento»: «Il posto di un vescovo è nel suo ovile e non a corte», e concludendo con questa brillante similitudine: «Non mi brucio le ali a questa fiamma». Quando la Savoia era in pericolo, lo supplicava insistentemente di portare il suo coraggio «alla difesa di questo sangue, di questa casa, di questa corona, di questo Stato».
Tuttavia, se Francesco di Sales è un servitore fedele, non è un cortigiano adulatore e interessato. Ci sono infatti molti modi di servire il principe:
Coloro che servono i principi per interesse rendono ordinariamente servizi più solleciti, più ardenti e sensibili; ma coloro che servono per amore li rendono più nobili, più generosi, e di conseguenza più stimabili.
In ogni caso, Francesco di Sales propugnava l’obbedienza come la prima virtù civica, certamente perché la considerava «una virtù morale che dipende dalla giustizia». La raccomandava a Filotea: «Dovete obbedire ai vostri superiori politici, cioè al vostro principe e ai magistrati che egli ha stabilito sul vostro paese». Fino alla fine della sua vita, Francesco di Sales diede prova di senso civico. Fu per obbedienza al duca che intraprese, nonostante il suo stato di salute, l’ultimo viaggio, che lo condusse ad Avignone e a Lione, dove morì.
Superare certe barriere sociali
La società in cui viveva Francesco di Sales era composta da strati molto diversificati e, per di più, separati da barriere. C’erano «gli ecclesiastici, i nobili, quelli di toga lunga, e il popolino o terzo stato».
Quando qualcosa andava storto, ognuno scaricava la responsabilità sugli altri, diceva in un sermone: il popolo accusa la nobiltà, la nobiltà incrimina i «ministri di giustizia», questi denunciano i soldati, i soldati scaricano la colpa sui capitani, i capitani denigrano i principi. In conclusione, «non è permesso sparlare senza pericolo, in questo tempo in cui siamo, di nessuno se non della Chiesa, della quale ognuno è censore, ognuno la sindaca (critica)». La conclusione è ovvia: che ognuno si esamini e si prenda le proprie responsabilità.
Se la divisione dei cittadini è un male che può produrre il peggio, l’unione fa la forza, come dice il proverbio. «Le sedizioni e i tumulti interni di una repubblica la rovinano completamente e le impediscono di poter resistere allo straniero». Quando c’erano «dissensi e varietà di concezioni», ricordava con fermezza che «l’unione e il legame degli spiriti» è «necessario a ogni buona impresa». In alcuni casi, il «bene della città» esigeva che alcuni rinunciassero alla «loro particolare opinione» e che ci si decidesse a «riprendere di nuovo il consenso generale, per opporlo al giudizio dei singoli».
Persino alle religiose della Visitazione bisognava ricordare il principio dell’uguaglianza delle persone e denunciare all’occorrenza questa grande miseria degli onori: «Ci si sovrastima al di sopra degli altri e si arriva poi a dire: Io sono di una tale casata e quella di un’altra». Un giorno, raccontò loro la storia della figlia di un maresciallo, che non riusciva a risolversi a chiamare «sorella» un’altra religiosa di umili origini. Bisognava secondo lui spogliarsi «del desiderio di essere stimato di buona casata e qualcosa di più degli altri». Esclamò persino:
Oh! siamo tutti uguali, perché siamo tutti figli dello stesso padre e della stessa madre, Adamo ed Eva; è dunque una grande follia gloriarsi della propria stirpe.
Quando la giustizia è lesa
Un buon cittadino si caratterizza per il suo senso della giustizia. Sfortunatamente, le occasioni per denunciare le ingiustizie non mancano. Francesco di Sales vi si dedicava frequentemente dal pulpito. Fu così che nel suo ardore di giovane predicatore, un giorno se la prese a turno con diverse categorie di fraudolenti: l’artigiano, « che vende troppo cara la sua merce»; il litigioso, «che per una minuzia intrattiene un processo che rovina l’anima, il corpo e la casa di due misere parti»; il giudice, poco sollecito nel rendere giustizia e «che la tira così per le lunghe, si scusa con diecimila ragioni di consuetudine, di stile, di teoria, di pratica e di cautela»; l’usuraio, che inganna se stesso facendo mentire la Scrittura; i preti, che si lusingano con dispense per servire due padroni; e le dame, che si compiacciono di essere corteggiate «scusandosi di non compiere atti contrari al loro onore». Le pratiche commerciali, pensava, raramente avvengono senza inganno, il che gli faceva dire che «i compratori e i venditori sono ordinariamente ladri, se non sono timorati e non hanno grande cura di vegliare sul loro cuore».
In alcune circostanze particolari, il vescovo sapeva benissimo che le buone parole e le elemosine non bastavano; si faceva allora un dovere di intervenire direttamente presso le autorità competenti per difendere i diritti delle persone minacciate. Poiché «non bisogna solo disporsi a non trascurare l’innocente, scriveva, ma bisogna unirsi a lui per la difesa della sua causa».
In periodo di carestia, se la prendeva con le «dame che uccidono pecore per nutrire un cagnolino codardo e poltrone». Durante i conflitti armati, sollecitava per il suo «povero buon popolo» l’esenzione dagli oneri di guerra e invocava la protezione e le elemosine del re sui cattolici della regione di Gex. La legge evangelica esclude ogni guerra, ricorda Francesco di Sales, che aggiungeva: «tuttavia, la guerra è permessa a causa della malizia degli uomini: si può respingere la forza con la forza». La cosa peggiore sono le persone che ne approfittano, «che vi si arricchiscono e ingrassano».
La giustizia appare spesso un’impresa ardua in questo mondo, sempre instabile, che oscilla incessantemente tra l’inferno e il paradiso. Se per i cristiani queste due realtà fanno parte dell’aldilà, se ne trovano tuttavia immagini suggestive quaggiù.
Quando qualcuno vive in «una calamitosa repubblica, tiranneggiata» da un «re maledetto», è l’inferno; gli abitanti vi «soffrono tormenti indicibili»; gli occhi vedono «l’orribile visione dei diavoli e dell’inferno»; le orecchie non sentono mai altro che «pianti, lamenti e disperazioni».
Il paradiso, al contrario, è una «città felice», dove tutti vivono «nella consolazione di una società felice e indissolubile». Che bello considerare «la nobiltà, la bellezza e la moltitudine dei cittadini e abitanti di questo felice paese»! E Francesco di esclamare: «Oh! quanto è desiderabile e amabile questo luogo, quanto è preziosa questa città!» o ancora: «Oh! quanto è felice questa compagnia!»
Naturalmente, la città ideale non esiste sulla terra, ma non è una ragione per non lavorare a renderla un po’ meno indegna di un tale modello. Giustizia e pace sono i beni che reclama la società civile e la «repubblica cristiana». Ora, «bisogna cedere alla necessità del prossimo», quando quest’ultimo li reclama a gran voce.
«La repubblica dipende dalla religione» e «la religione dipende dalla repubblica»
Uomo di Chiesa prima di tutto, Francesco di Sales voleva essere estraneo agli affari direttamente politici. In un tempo di controversie con i protestanti in cui i cattolici e persino numerosi religiosi erano portati verso la politica e le soluzioni politiche, egli distingueva nettamente gli ambiti, ammettendo una certa forma di autonomia del temporale. Scriveva al governatore di Savoia:
Quanto a me, vi dichiaro che ignoro gli affari di Stato, e li voglio ignorare a tal punto che non siano né nel mio pensiero, né nella mia cura, né sulla mia bocca, se non si presentasse qualche occasione di testimoniare a Sua Altezza che sono il suo appassionato e fedele suddito.
Il vescovo voleva prima di tutto formare buoni ministri di Dio. Per lui, il prete non doveva immischiarsi in questioni temporali e politiche. Farà la stessa raccomandazione al futuro cardinale Richelieu, che incontrò a Tours nel 1619 quando era ancora solo vescovo di Luçon, ma già segretario di Stato. Scriverà alla madre de Chantal:
Ho avuto modo di conoscere moltissimi prelati, e in particolare Mons. il vescovo di Luçon, che mi ha giurato amicizia e mi ha detto che alla fine si sarebbe schierato dalla mia parte, per non pensare più che a Dio e alla salvezza delle anime.
Il seguito mostrerà che questi buoni propositi non dureranno, o almeno che il cardinale li interpreterà a modo suo.
Bisognava per questo disinteressarsi della felicità temporale dei propri compatrioti? «Chi non ama molto la cosa pubblica, non si dà molta pena se essa va in rovina», scrive nel Trattato dell’amor di Dio. La politica, d’altronde, non è estranea alla religione e alla coscienza. Contro il ministro protestante che voleva separare i due ambiti, col pretesto che l’onore è dovuto solo a Dio, l’autore della Difesa dello Stendardo della Santa Croce replicava «che è tagliare troppo dall’onore dovuto a Dio toglierne quello civile e politico».
Francesco di Sales non era dunque tentato di eliminare la religione dalla vita pubblica. Pur ammettendo una certa laicità dello Stato, o almeno una diversificazione dei compiti civili e religiosi, pensava che i principi avessero interesse a riflettere sui vantaggi della religione. Dal canto suo, la Chiesa non esitava a «implorare» il soccorso del «braccio secolare», soprattutto quando il cattolicesimo era minacciato o la moralità era in pericolo.
Secondo san Francesco di Sales, «la repubblica dipende dalla religione come il corpo dall’anima, e la religione dalla repubblica come l’anima dal corpo». Unione e distinzione erano i due principi che governavano secondo lui i rapporti tra Chiesa e Stato. L’idea di separazione non rientrava in questo schema, il cui modello era nei rapporti tra corpo e anima. La sventura era che la politica si serviva della religione e che il potere spirituale era come infeudato al potere temporale del principe. Il vescovo di Ginevra se ne lamentava con il suo amico, il vescovo di Belley:
Quale abiezione che noi abbiamo la spada spirituale in mano e che, come semplici esecutori delle volontà del magistrato temporale, ci tocchi colpire quando egli lo ordina e cessare quando egli lo comanda, e che siamo privati della chiave principale tra quelle che Nostro Signore ci ha dato, che è quella del giudizio, del discernimento e della scienza nell’uso della nostra spada!
Il suo atteggiamento di suddito obbediente del duca di Savoia si accompagnava a un illuminato senso dei propri diritti. Si considerò sempre principe di Ginevra, cioè legittimo sovrano temporale della città di cui Calvino e il partito ugonotto avevano preso il controllo. Nel dicembre 1601, su richiesta di Mons. de Granier, aveva redatto una memoria destinata a fornirne le prove storiche. L’inizio, più che mai chiaro, dichiarava che il vescovo di Ginevra è «l’unico legittimo principe sovrano di Ginevra e delle sue dipendenze, nonostante i signori duchi di Savoia, come successori dei conti di Ginevra da una parte e i cittadini di Ginevra dall’altra, pretendano il contrario».
Infine, per garantire la pace degli Stati e della Chiesa, era meglio non agitare troppo certe questioni relative all’autorità della Santa Sede negli affari temporali, in particolare per quanto riguardava il potere del papa di deporre i re. Quando Roberto Bellarmino, «quel grande e celebre cardinale», «quel teologo eccellentissimo», scrisse per ordine del papa che il potere di quest’ultimo si estendeva anche al temporale dei re, Francesco di Sales non ne fu contento e lo scrisse a uno dei suoi amici di tendenze gallicane:
No, non ho nemmeno gradito certi scritti di un santo ed eccellentissimo prelato, nei quali ha toccato del potere indiretto del papa sui principi; non che io abbia giudicato se ciò sia o non sia, ma perché in quest’epoca in cui abbiamo tanti nemici fuori, credo che non dobbiamo smuovere nulla all’interno del corpo della Chiesa.
Cittadino del mondo
L’educazione del buon cittadino in una visione umanistica non può limitarsi alla piccola patria e uno dei suoi compiti consiste nel coltivare il senso dell’universale. La conoscenza degli altri popoli del mondo era facilitata dalla creazione delle prime carte geografiche:
Coloro che in quattro o cinque fogli di carta mostrano Roma, Parigi, Vienna e le più grandi città di Francia, segnano con piccoli punti quali sono la grandezza e la situazione dei luoghi, sebbene ciò non sia nulla in confronto a ciò che è; ma coloro che capiscono e che conoscono la geografia capiscono da ciò che cosa sono Parigi, Roma, Vienna e altre.
Amare il proprio paese non autorizza il disprezzo degli altri. L’autore dell’Introduzione mette in guardia contro un’abitudine in cui «ciascuno si prende la libertà di giudicare e censurare i principi e di sparlare di intere nazioni, secondo la diversità degli affetti che si hanno nei loro confronti». Secondo uno dei suoi familiari, il vescovo di Ginevra «aveva in orrore ogni denigrazione e non approvava nemmeno che si alludesse a quei vizi che gli autori attribuiscono di solito a certe nazioni».
Il cristiano soprattutto è aperto per principio al mondo intero: se voglio solo la volontà di Dio, esclamava, «che m’importa che mi si mandi in Spagna o in Irlanda? E se non cerco che la sua croce, perché mi dispiacerà che mi si mandi nelle Indie, nelle terre nuove o nelle vecchie, poiché sono sicuro che la troverò ovunque?»
Un modo concreto di aprirsi all’universale è l’apprendimento delle lingue. Ammirava Mitridate, re del Ponto, che, secondo Plinio, «conosceva ventidue lingue». Nella sua orazione funebre per il duca di Mercœur, lodava questo grande personaggio perché «aveva anche l’uso dell’eloquenza e la grazia di esprimere bene le sue belle concezioni, non solo in questa nostra lingua francese, ma anche in tedesco, italiano e spagnolo»; alla testa delle sue truppe, sapeva «parlare a ciascuno nella sua propria lingua, francese, tedesco, italiano».
La sua apertura all’universale si farà sentire sempre di più man mano che avanzerà in età ed esperienza. Verso la fine della sua vita, per mostrare la sua perfetta indifferenza di fronte ai viaggi e alle missioni che lo attendevano fuori dalla Savoia, scriverà questa significativa dichiarazione: «Non sono più di questo paese, ma del mondo».