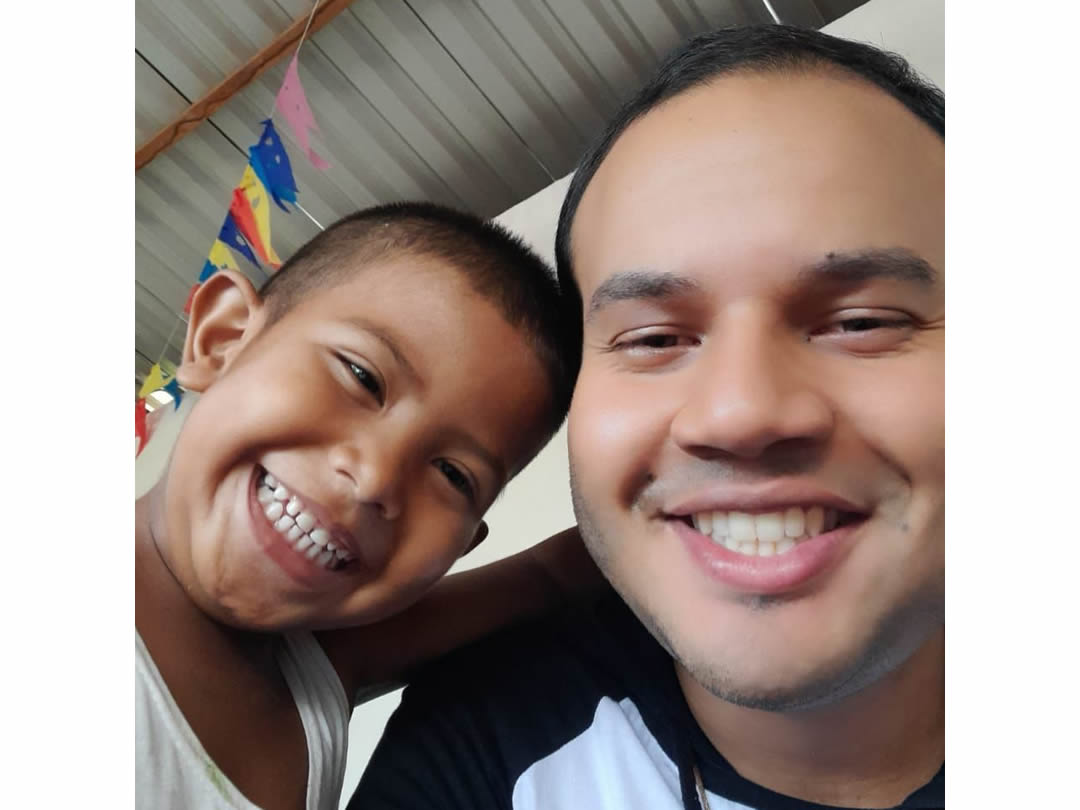Volontariato internazionale a Benediktbeuern
Don Bosco Volunteers: l’impegno dei giovani per un futuro migliore
Da più di vent’anni l‘Ispettoria tedesca dei Salesiani di Don Bosco è impegnata nel campo del volontariato giovanile. Tramite il programma “Don Bosco Volunteers” i Salesiani in Germania offrono ogni anno a circa 90 giovani un’esperienza formativa e di vita nelle case salesiane dell’Ispettoria e in diversi paesi del mondo.
Per molti giovani tedeschi è consuetudine, una volta completato il percorso formativo scolastico, dedicare un anno della loro vita ad attività nel sociale. Il profilo dei Salesiani rappresenta per molti giovani tedeschi una fonte d’ispirazione nella scelta di un’organizzazione, che li accompagni durante questa esperienza. Nonostante la secolarizzazione della società tedesca e una costante perdita di fedeli da parte della Chiesa negli ultimi anni, molti giovani bussano alla porta dei Salesiani con la chiara intenzione di aiutare il prossimo e dare un piccolo contributo per un mondo migliore. Questi giovani trovano nella figura di don Bosco una forma di fede e un esempio di vita.
Non tutti coloro i quali fanno richiesta d’ammissione al programma di volontariato presso gli uffici competenti dell’Ispettoria a Benediktbeuern e a Bonn hanno avuto nel corso della loro vita esperienze in gruppi giovanili legati alla Chiesa e in particolar modo con i Salesiani. Alcuni di loro non sono battezzati, ma riconoscono nell’offerta formativa dei Salesiani una possibilità di crescita personale, basata su valori fondamentali per il proprio sviluppo. È per questo che ogni anno tantissimi giovani cominciano un’esperienza di volontariato con il programma “Don Bosco Volunteers”: nell’ambito di weekend formativi, i giovani apprendono non solo utili informazioni sui progetti, ma si confrontano con il sistema preventivo e la spiritualità salesiana, preparandosi in questo modo al periodo che metteranno a servizio di altri giovani.

I volontari e le volontarie vengono accompagnati durante la loro esperienza da un team di coordinatori e coordinatrici, che si prende cura non solo degli aspetti organizzativi, ma soprattutto del supporto prima, durante e dopo l’esperienza di volontariato. E sì, perché l’anno di volontariato non finisce l’ultimo giorno di servizio presso la casa salesiana ospitante, ma continua per tutta la vita. Quest’anno al servizio degli altri rappresenta una base di valori che ha un forte impatto sullo sviluppo futuro delle volontarie e dei volontari. Don Bosco educava i giovani per far di loro degli onesti cittadini e dei buoni cristiani: l’offerta di volontariato del programma Don Bosco Volunteers s’ispira proprio a questo principio fondamentale della pedagogia salesiana e cerca di gettare le basi per una società migliore, in cui i valori cristiani ritornino a caratterizzare la nostra vita.
L’Ispettoria tedesca mette a disposizione possibilità d’incontro per i giovani in tutte le fasi dell’esperienza di volontariato: incontri d’orientamento, offerte informative online, corsi di formazione, feste e incontri annuali di scambio d’esperienze sono attività di base su cui si costruisce il successo del programma “Don Bosco Volunteers”.
Un gruppo di coordinamento formato da collaboratori e collaboratrici del centro di formazione giovanile Aktionszentrum di Benediktbeuern e della Procura Missionaria di Bonn, affiancato dall’economo ispettoriale padre Stefan Stöhr e dall’incaricato per la pastorale giovanile padre Johannes Kaufmann, gestisce e dirige ciascuna attività, sviluppando il programma in tutte le sue componenti. L’esperienza dei volontari inizia con la richiesta d’ammissione all’iniziativa: i giovani che prendono parte al programma nazionale cominciano il servizio a settembre e partecipano a 25 giornate formative durante l’anno di volontariato. Per i volontari e le volontarie che intendono andare all’estero il percorso è un po’ più articolato: dopo un incontro d’orientamento, in autunno vengono effettuate le selezioni e le candidate e i candidati ricevono informazioni da ex volontarie e volontari che hanno già preso parte al programma in passato. La fase formativa comincia nei primi mesi dell’anno e prevede in tutto 12 giorni di preparazione, durante i quali le volontarie e i volontari ricevono informazioni sulla pedagogia di don Bosco, sul lavoro dei Salesiani nel mondo, su temi importanti come la comunicazione interculturale e le procedure da seguire in caso d’emergenza durante l’esperienza all’estero. A luglio le volontarie e i volontari ricevono la benedizione e una medaglia di don Bosco come simbolo dell’appartenenza alla Famiglia Salesiana.
La partenza dei giovani è prevista a settembre e, verso la metà del servizio, nelle diverse regioni in cui operano i volontari vengono offerti degli incontri di riflessione tenuti dal team di coordinamento dell’Ispettoria tedesca. L’esperienza si chiude con un seminario conclusivo, poco dopo il rientro dall’attività all’estero, in cui vengono gettate le basi per un impegno futuro nella Famiglia Salesiana. A cadenza annuale nell’Ispettoria vengono organizzati due incontri per tutti coloro che hanno preso parte al programma sin dall’inizio delle attività negli anni Novanta. Il team di coordinamento dell’Ispettoria si prende cura di tutti gli aspetti organizzativi tra i quali: ricerca di case salesiane interessate a collaborare nel campo del volontariato; finanziamento delle attività tramite i fondi ministeriali ed europei; supporto in caso d’emergenza; organizzazione degli aspetti legati all’assicurazione sanitaria dei volontari; comunicazioni con le famiglie delle volontarie e dei volontari.

Negli ultimi 25 anni, sono già più di mille i giovani che hanno preso parte al programma “Don Bosco Volunteers” in Germania e all’estero.
Nell’ambito di uno studio condotto alcuni mesi fa dall’Ispettoria tedesca, a cui hanno partecipato circa 180 ex volontarie e volontari, si è potuto riscontrare un costante impegno nel sociale dei giovani anche molti anni dopo l’esperienza di volontariato. In modo particolare, è evidente l’attenzione degli intervistati riguardo a temi come l’ingiustizia sociale, il razzismo, l’ecologia e lo sviluppo sostenibile. Tale studio ha confermato tutta la bontà di questo programma, non solo per l’aiuto immediato che le volontarie e i volontari possono fornire alle comunità ospitanti durante il proprio anno di servizio, ma anche per gli effetti positivi che si possono registrare a lungo termine, una volta conclusi gli studi accademici o dopo aver intrapreso il proprio cammino professionale.
Un aspetto importante del programma “Don Bosco Volunteers” è il suo inquadramento in programmi nazionali ed europei, come ad esempio il “Corpo europeo di solidarietà” della Commissione Europea, i programmi di volontariato nazionale del Ministero per la famiglia e la gioventù o del programma “weltwärts” del Ministero Federale per la Cooperazione Economica, in modo da poter rendere più visibile alle istituzioni l’offerta formativa dei Salesiani. Costanti controlli di qualità, condotti da associazioni competenti, certificano su base biennale l’efficienza e la trasparenza dell’offerta formativa del programma “Don Bosco Volunteers”. Un aspetto di questi controlli di qualità riguarda in particolare la cooperazione tra i nostri uffici competenti e le strutture ospitanti in Germania e nei diversi Paesi del mondo. Questo particolare distingue l’offerta dei Salesiani da molte altre agenzie private di volontariato, che collaborano con diverse organizzazioni dai profili più svariati.
Le nostre volontarie e i nostri volontari operano esclusivamente in strutture salesiane e vengono preparati in modo specifico per questa esperienza di vita. Non ha importanza se un volontario sia impiegato in un piccolo villaggio nel sud dell’India o in una metropoli europea. C’è qualcosa che unisce tutti questi giovani e li fa sentire a casa durante la loro esperienza: don Bosco con la sua presenza nelle comunità ospitanti offre loro un punto di riferimento nella quotidianità e dà loro conforto e protezione nei momenti più difficili. Ovviamente sarebbe semplicistico raccontare che un’esperienza di volontariato si svolge sempre senza intoppi o problemi: la fase d’ambientamento, in particolare, può creare diversi problemi d’integrazione per le volontarie e i volontari. Ma è proprio in queste situazioni che si può constatare una crescita dei giovani, i quali imparano a conoscere meglio se stessi, i propri limiti e le proprie risorse. L’accompagnamento fornito dalle comunità salesiane ospitanti e dal personale dei centri di coordinamento dell’Ispettoria tedesca ha il fine di trasformare anche le fasi più difficili di questo cammino in opportunità di riflessione e crescita personale. Molte sfide ci attendono nel futuro: gli ultimi due anni ci hanno mostrato che il mondo sta cambiando e il timore che la guerra cancelli la prospettiva di una società più equa sembra crescere nelle nuove generazioni. Il programma “Don Bosco Volunteers” vuole essere un barlume di luce e una fonte di speranza, affinché i nostri giovani possano costruire, attraverso il loro impegno, un futuro migliore per il nostro pianeta.
Francesco BAGIOLINI
Benediktbeuern, Germania