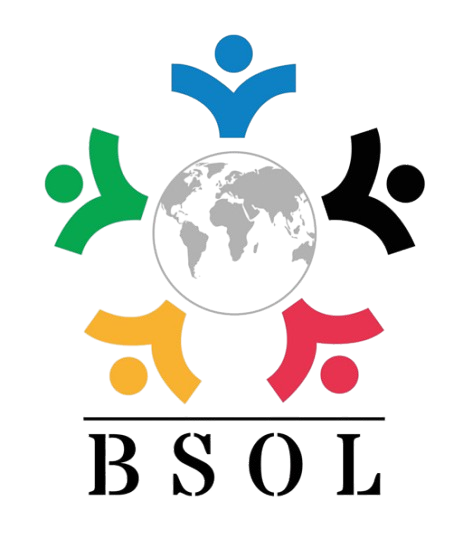Tempo per lettura: 3 min.
In questo brano, tratto dai ricordi del 1887, don Giovanni Bosco affida alla pagina la più inquietante delle sue visioni oniriche: la discesa nelle pene dell’inferno. Il sogno, avuto nella notte fra il 2 e il 3 aprile, lo lasciò stremato e tremante, tanto forte era stata la sensazione di trovarsi davanti alla sorte eterna dei peccatori. Attraverso rumori tellurici, grida disumane e figure mostruosamente deformate, il santo educatore intende ammonire i giovani sul destino che attende chi si vanta dei beni terreni e trascura l’anima. La narrazione, intensa e quasi cinematografica, culmina in un invito pressante alla preghiera e alla comunione frequente, unici rimedi capaci di spezzare le catene del male e orientare definitivamente la vita verso la salvezza.
La mattina del 3 aprile disse a Don Viglietti che nella notte precedente non aveva potuto prendere riposo, ripensando a un sogno spaventoso fatto nella notte del 2. Tutto questo aveva prodotto in lui un vero esaurimento di forze.
– Se i giovani, gli diceva, udissero il racconto di quello che vidi, o si darebbero a una vita santa o fuggirebbero spaventati per non ascoltare sino alla fine. Del resto mi è impossibile descrivere ogni cosa, come sarebbe difficile rappresentare nella loro realtà i castighi riserbati ai peccatori nell’altra vita.
Egli aveva veduto le pene dell’inferno. Sentì prima un gran rumore come di terremoto. Lì per lì non vi fece gran caso; ma il rumore andava gradatamente crescendo, finché udì un rombo prolungatissimo, terrificante, misto a grida di orrore e di spasimo, voci umane inarticolate che confuse col fragore generale producevano un fracasso pieno di spavento. Sbigottito osservò intorno a sé qual potesse essere la causa di quel finimondo, ma non scorse nulla. Il rumore ognor più assordante si avvicinava, né più si poteva con gli occhi o con le orecchie distinguere ciò che avvenisse. Don Bosco continuò così a descrivere:
– Vidi dapprima come una massa, un volume informe che man mano prese la figura di una formidabile botte di favolose dimensioni: di là uscivano le grida di dolore. Domandai spaventato che cosa fosse, che cosa significasse quanto io vedeva. Allora le grida, fino a quel punto inarticolate, si fecero più forti e più distinte, sicché percepii queste parole: Multi gloriantur in terris et cremantur in igne (Molti si vantano sulla terra, ma bruceranno nel fuoco). Poi vidi per entro a quella specie di botte persone d’indescrivibile deformità. Gli occhi uscivano dalle orbite; le orecchie quasi staccate dal capo pendevano all’ingiù; le braccia e le gambe erano slogate in modo raccapricciante. Ai gemiti umani si univano sguaiati miagolii di gatti, rabbiosi abbaiamenti di cani, ruggiti di leoni, urli di lupi, voci di tigri, di orsi e di altri animali. Osservai meglio e fra quegli sventurati ne riconobbi alcuni. Allora sempre più esterrefatto domandai nuovamente che cosa volesse significare si straordinario spettacolo. Mi fu risposto: Gentilibus inenarrabilibus famem patientur ut canes (I gentili soffrono una fame indicibile come i cani).
Intanto col crescere del rumore cresceva innanzi a lui più viva e più distinta la vista delle cose; meglio conosceva quegli infelici, più chiare gli giungevano le loro strida, più opprimente si faceva il suo terrore. Interrogò gridando: Ma non vi potrà dunque essere rimedio né scampo a tanta sventura? È proprio per noi tanto apparato di orrore, sì tremenda punizione? Che cose debbo fare io?
– Sì, gli rispose una voce, vi è un rimedio, un rimedio solo. Affrettarsi a pagare i propri debiti con oro e argento.
– Ma queste sono cose materiali.
– No; aurum et thus (oro e incenso). Con la preghiera incessante e con la frequente comunione si potrà rimediare a tanto male.
Durante questo dialogo più strazianti si facevano udire le grida, più mostruosi comparivano dinanzi a lui gli aspetti di coloro che le emettevano, sicché, preso da mortale terrore, si svegliò. Erano le tre del mattino, né gli fu più possibile chiudere occhio. Nel corso del suo racconto un tremito gli agitava le membra, aveva il respiro affannoso e lacrimava.
(MB XVIII, 284-285)