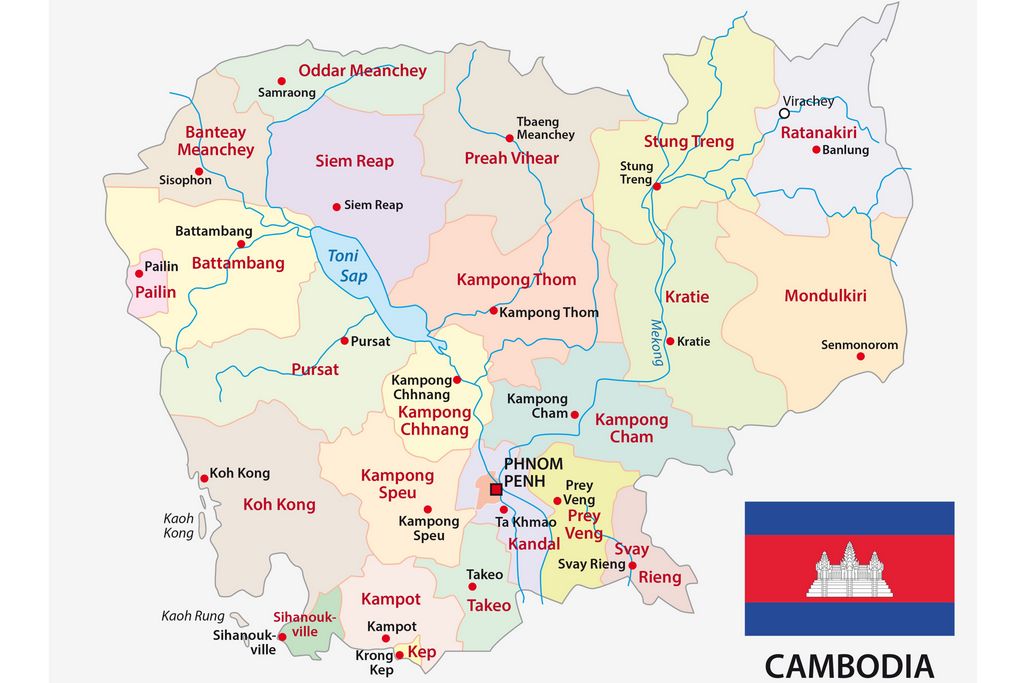Il cuore d’oro dell’educazione
Perché la devozione al Sacro Cuore di Gesù fa parte del DNA della Congregazione Salesiana.
Una gran bella chiesa che è costata “sangue e lacrime” a Don Bosco, che, già consumato dalla fatica, spese le sue ultime energie e anni nella costruzione di questo tempio richiesto dal Papa.
È un luogo caro a tutti i Salesiani anche per tanti altri motivi.
La statua dorata del campanile, per esempio, è un segno di riconoscenza: è stata donata dagli ex allievi argentini per ringraziare i Salesiani perché erano venuti nella loro Terra.
Anche perché in una lettera del 1883, don Bosco ha scritto la frase memorabile: «Ricordatevi che l’educazione è cosa di cuore, e che Dio solo ne è il padrone, e noi non potremo riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna l’arte, e non ce ne dà in mano le chiavi». La lettera terminava così: «Pregate per me, e credetemi sempre nel SS. Cuore di Gesù».
Perché la devozione al Sacro Cuore di Gesù fa parte del DNA salesiano.
La festa del Sacro Cuore di Gesù vuole incoraggiarci ad avere un cuore vulnerabile. Soltanto un cuore che può essere ferito è in grado di amare. Così, in questa festa, contempliamo il cuore aperto di Gesù per aprire anche i nostri cuori all’amore. Il cuore è il simbolo ancestrale dell’amore e molti artisti hanno dipinto la ferita al cuore di Gesù con l’oro. Dal cuore aperto si irraggia verso di noi il fulgore dorato dell’amore, e la doratura ci mostra inoltre che le nostre fatiche e le nostre ferite possono tramutarsi in qualcosa di prezioso.
Ogni tempio e ogni devozione al Sacro Cuore di Gesù parla dell’Amore di quel cuore divino, il cuore del Figlio di Dio, per ciascuno dei suoi figli e figlie di questa umanità. E parla di dolore, parla di un amore di Dio che non sempre viene ricambiato. Oggi aggiungo un altro aspetto.

Penso che parli anche del dolore di questo Gesù Signore di fronte alla sofferenza di molte persone, allo scarto di altre, all’immigrazione di altre persone senza un orizzonte, alla solitudine, alla violenza che molte persone subiscono.
Penso che si possa dire che parla di tutto questo, e allo stesso tempo benedice, senza dubbio, tutto ciò che viene fatto a favore degli ultimi, cioè la stessa cosa che faceva Gesù quando percorreva le strade della Giudea e della Galilea.
Per questo è un bel segno che la Casa del Sacro Cuore sia ora la sede centrale della Congregazione.
Tanti cuori d’argento
Una di queste realtà gioiose che indubbiamente allietano il “Cuore di Dio stesso” è quella che ho potuto constatare di persona, ovvero ciò che si sta facendo presso la Fondazione salesiana Don Bosco nelle isole di Tenerife e Gran Canaria. La scorsa settimana sono stato lì e, tra le tante cose che ho vissuto, ho potuto vedere i 140 educatori che lavorano nei vari progetti della Fondazione (accoglienza, alloggio, formazione al lavoro e successivo inserimento lavorativo). E poi ho incontrato un altro centinaio di adolescenti e giovani che usufruiscono di questo servizio di Don Bosco per gli ultimi. Al termine del nostro prezioso incontro, mi hanno fatto un regalo.
Mi sono commosso perché nel lontano 1849 due ragazzini, Carlo Gastini e Felice Reviglio, avevano avuto la stessa idea e, in gran segreto, risparmiando sul cibo e conservando gelosamente le loro piccole mance, erano riusciti a comperare un regalo per l’onomastico di don Bosco. La notte di San Giovanni erano andati a bussare alla porta della camera di don Bosco. Pensate la sua meraviglia e commozione nel vedersi presentare due piccoli cuori d’argento, accompagnati da poche impacciatissime parole.
Il cuore dei ragazzi è sempre lo stesso e anche oggi, nelle Canarie, in una piccola scatola di cartone a forma di cuore, hanno messo più di cento cuori con i nomi di Nain, Rocio, Armiche, Mustapha, Xousef, Ainoha, Desiree, Abdjalil, Beatrice e Ibrahim, Yone e Mohamed e cento altri, esprimendo semplicemente qualcosa che veniva dal cuore; cose sincere di grande valore come queste:
– Grazie per aver reso possibile tutto questo.
– Grazie per la seconda possibilità che mi hai dato nella vita.
– Continuo a lottare. Con te è più facile.
– Grazie perché mi hai ridato la gioia.
– Grazie per avermi aiutato a credere che posso fare tutto ciò che mi prefiggo.
– Grazie per il cibo e la casa.
– Grazie dal profondo del mio cuore.
– Grazie per avermi aiutato.
– Grazie per questa opportunità di crescita.
– Grazie per aver creduto in noi giovani nonostante la nostra situazione…
E centinaia di espressioni simili, rivolte a don Bosco e agli educatori che in nome di don Bosco sono con loro ogni giorno.
Ho ascoltato quello che hanno condiviso con me, ho sentito alcune delle loro storie (molte delle quali piene di dolore); ho visto i loro sguardi e i loro sorrisi; e mi sono sentito molto orgoglioso di essere un salesiano e di appartenere a una famiglia di fratelli, educatori, educatrici e giovani così splendidi.
Ho pensato, ancora una volta, che don Bosco è più attuale e necessario che mai; e ho pensato alla finezza educativa con cui accompagniamo tanti giovani con grande rispetto e sensibilità per i loro sogni.
Abbiamo recitato insieme una preghiera rivolta al Dio che ci ama tutti, al Dio che benedice i suoi figli e le sue figlie. Una preghiera che ha fatto sentire a proprio agio cristiani, musulmani e indù. In quel momento senza alcun dubbio lo Spirito di Dio ci abbracciava tutti.
Ero felice perché, come don Bosco a Valdocco accoglieva i suoi primi ragazzi, oggi, in tanti Valdocco nel mondo, sta accadendo la stessa cosa.
Quando parliamo dell’amore di Dio, per molti è un concetto troppo astratto. Nel Sacro Cuore di Gesù l’amore di Dio per noi è diventato concreto, visibile e percettibile. Per noi Dio ha preso un cuore umano, nel cuore di Gesù ci ha aperto il suo cuore. Così, attraverso Gesù, possiamo portare i nostri destinatari al cuore di Dio.